Ei vi fu nella Grecia un gran maestro,
che, o per desio di popolo devoto,
o per provvido impulso di sant’estro,
o per altro motivo a lui sol noto,
volle scolpir la Vergine beata
nell’atto ch’è dall’Angelo annunziata. Seco studiava un giovine avvenente,
un discepolo fiore d’intelletto,
che, nell’idee leggendo immantinente,
al maestro rubato avea il concetto;
ei dell’Angelo il viso e il vestimento
immagina e disegna in un momento. Non ha un masso di marmo, onde connette
i pezzi che il maestro butta via;
tacito e occulto all’opera si mette,
pregando il Cielo che favor gli dia;
ed è nel lavor suo molto inoltrato quando
quando quell’altro è bell’e terminato! Ora il maestro aveva stabilito
di dar principio a l’Angelo il dì dopo;
ma, avuto dal discepolo un invito,
a casa va di lui, dove lo scopo
d’un tal invito manifesto trova,
e del giovine l’opra ammira e approva. Ma tosto ammutolisce e atteggia il ciglio
sì che rivela il cor d’invidia pieno;
indi ratto a un martello dà di piglio
e il bel giovine fredda in un baleno! ...
In quel dì stesso l’invido omicida
è giustiziato tra plaudenti grida. Incompleto così l’Angelo resta
sol con un’ala, come ancor si vede.
Improvvisa quel popolo una festa
e, con fervido brio di viva fede,
porta que’ simulacri in un gran tempio
parato sì che pria non ebbe esempio. Nell’impero oriental dop’anni ed anni
del fatto esposto, un ordine apparisce,
che, seminando orror lacrime affanni,
il culto delle immagini abolisce.
Celatamente studiansi i Cristiani
che i simulacri lor rimangan sani. Ed una notte, a malincore poste
le statue nostre in larga navicella,
al mar le danno da rimote coste:
quand’ecco scatenarsi una procella,
che, contro ogni più lieto presagirè,
repente il caro legno fa sparire. Verso l’alba, sul mar, che da levante
gode i sorrisi del sicano lito,
la navicella appare sfolgorante:
è lo strano fenomeno avvertito
da poveri solerti pescatori,
usi di notte ai lor magri lavori. Guardan fermi e stupiti i paurosi;
ma quei, che sono attratti da rapina,
s’avanzano nell’acqua ardimentosi:
più lor la navicella si avvicina,
più perde a poco a poco la sua luce,
fin che, toccata, oscura si riduce. Trovate in fondo al cavo pin distese
le vaghe statue, dolce ammirazione
e ad un tempo timor sacro li prese;
han di rizzarle poi l’ispirazione,
perchè presto si vegga da la riva
la cosa molto singolar che arriva. | Sorto non era il sol: pel puro cielo
tutta gioconda distendea l’aurora
il suo rosato risplendente velo,
come più bel non s’era visto ancora;
e in quel leggiadro sfondo luminoso
si disegnava il legno portentoso. De’ Brontesi trovandosi in cammino,
per vendere l’albagio lor speciale,
di lì passano proprio quel mattino,
e s’arrestano ad un prodigio tale.
La navicella intanto adagio approda
e la gente affollata è in su la proda. Scoppia prima un gridìo di gioia intensa,
indi un alterco. La case meschine
vi son prive di chiesa; onde si pensa
dove posar le statue peregrine,
e chi di possederle n’abbia il dritto.
E’ si prevede facile un conflitto! Allor s’inoltra e parla un pio Brontese:
« Tutto l’albagio nostro offriamo a voi,
se le statue ci date; e le contese
intendiamo così troncarvi noi».
S’accoglie da ciascun quant’è proposto,
e il fortunato scambio si fa tosto. Cercano i nostri un carro e un par di bovi,
per portar via quell’onorato peso;
ma nessun di lor v’è che li trovi;
uno però sull’imbrunire ha inteso,
che due tori fortissimi vi sono,
di cui certo il padron farebbe dono. La mattina di poi s’alzano presto,
e a l’indicato loco se ne vanno;
vi trovan il padron da un’ora desto,
e subito da lui que’ tori s’hanno,
i quali son feroci, errano intorno,
e nessun loro ha mai toccato un corno. Tosto ch’ebbero i nostri quel permesso,
come agnello festante e mansueto
accorre ciascun toro da se stesso,
quasi a chiedere un giogo consueto:
è questo, pel padron, celeste indizio,
e un carro novo ei pone a lor servizio. Quando tai bestie trovansi davanti
ai sacri marmi, danno de’ muggiti
e cadono in ginocchio; onde gli astanti
rimangono a mirarle sbalorditi,
e i nostri fan la prima lor gridata:
Viva Maria santissima Annunziata! Posti sul carro i simulacri ritti,
s’alzano i tori e, senza verun cenno,
per Bronte s’incamminano diritti,
quali viaggiator d’esperto senno;
e allor più fragorosa è la gridata:
Vita Maria santissima Annunziata! La strada non è sempre aperta e piana,
pel bosco è duro del carro il passaggio;
ma l’un alber da l’altro s’allontana,
mentre s’infiora il suol più che di maggio,
sì che spesso risuona la gridata:
Viva Maria santissima Annunziata! | Quei tori, che non sentono comando,
giunti qua, sull’entrar del paesello
da la parte di giù, ristan guardando
il torbido e fumante Mongibello;
smuover niun li può, s’alza un vociare:
« Qui, la Madonna qui vuole un altare!» Inteso ciò, gli immobili animali
si movon gravemente in certo giro,
e tanti e tanti fanno giri eguali,
che alfin lo scopo tutti ben capiro:
passando è ripassando restò un segno,
che d’un tempio era artistico disegno. S’erige il tempio che da noi s’ammira;
ogni lustro decretasi un festino
nel caldo mese, quando un po’ respira
da l’improbe fatiche il contadino;
l’Annunziata s’intitola Patrona,
e d’oro le si fa manto e corona. Ma un dì l’Etna si sveglia: il suol si move
con tremendi sussulti, il ciel s’oscura,
e bruna rena chetamente piove;
d’un subito s’accresce la paura,
la tenebrìa s’arrossa e si distende
e verso Bronte accesa lava scende. La gente nostra credesi perduta,
chè a tal periglio non può nulla opporre;
a le sue colpe il gran flagello imputa,
e, con vivida fede, al tempio accorre:
indi la statua di Maria in un loco
porta, che guardi l’invadente foco. Pregano tutti e non v’è asciutto un occhio;
la scena è spaventevole e pietosa;
quando quell’alma statua, ch’è in ginocchio,
in pìè tosto si leva e imperiosa
comanda all’ìgneo fiume mutar corso:
apparve pronto il sovruman soccorso! La Vergine, com’è, rimase ritta,
sì che non pare nel solenne istante,
che il fiat cede a l’ansia terra afflitta;
ma il fedel, che s’inchina a lei dinante,
più sensibile vede la divina
maestà della sua Madre e Regina. 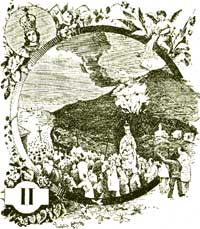
Leggi pure - Il gruppo marmoreo del Gagini
- L'Annunziata, Patrona di Bronte
- Bronte e la devozione alla Annunziata |