15. Il Collegio Capizzi
Parte prima, Parte seconda, Parte terza
Le Regole del Collegio
“Il Collegio divenne la sorgente, alla quale i cittadini attinsero nell’avvenire e lavoro e sapere. E […] il paese circondò il Collegio delle sue cure più amorevoli. […] Fu una nobile e santa gara di beneficenza e di carità patria.(1a)
“Il santo vecchio intanto ritorna a Palermo alle sue fatiche. Di là veglia con cuore di padre alla fortuna della novella Casa della quale, nell’ottobre del 1779, i deputati approvano il primo bilancio(1b); porge consigli al rettore come comportarsi cogli alunni insolenti; esorta superiori e maestri a mostrarsi disinteressati per l’opera. “Dopo due anni nel settembre del 1780 col sac. Lanza ed altri confratelli del Fervore, rivide, e fu l’ultima volta, la patria e la Casa. […] “Il Capizzi intanto, ricordando non senza rammarico, come l’Ospedale ricavava dallo Stato di Bronte e di Maniace 75 mila ducati, avea fin dal 13 settembre 1777, fatta istanza a quei rettori, che, almeno su quella somma, si assegnassero onze 60 all’anno alla novella Casa. I Rettori cedettero e concesero (obtorto collo!) in perpetuo le supplicate onze 60. […]
Sollecitava pure il Capizzi, il più che gli premeva, le regole per il governo della nuova Casa, che in quell’ intervallo, credo si governasse con le regole del Seminario di Monreale; e per la formazione delle quali sin dal 18 dicembre 1778 egli aveva presentato un memoriale al governo di Sicilia. Il Vice-re per consiglio della Giunta dei presidenti, ne diede a lui stesso l’incarico. Egli si mise subito all’opera e nel 16 marzo del 1781 le presentò all’esame della Giunta, che nel 14 aprile ne riferì favorevolmente al Vicere e questi, a consiglio della stessa, diede al vecchio venerando la facoltà e l’onore di eleggere egli i primi deputati(1c).” Il Capizzi impedì che alcuni sacerdoti entrassero “come preti operai nella Casa. […] Col consiglio del Marvuglia, dovendosi rinnovare parte del disegno, inviava a Bronte un fratello cappuccino per lavorare insieme col Lupo capomastro conduttore preposto alla fabbrica. Raccomandava al Rettore e ai deputati di non buttare giù il teatrino, luogo di godimento dei signori gentiluomini per non disgustarsi con loro che sono i principali del paese […]. Sebbene assorto in Dio, non mancava di certi pratici e scaltri suggerimenti diretti sempre al bene dell’ opera, che altri potrebbe dire machiavellici. […] Così egli evitava difficoltà spiacevoli, e arrivava sicuro al suo scopo. 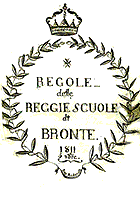 “Le regole che il Capizzi scrisse per il suo Istituto sono il frutto della sua lunga esperienza. Quelle riguardanti gli studi hanno, in gran parte, addentellato con le regole che il padre Fazio gesuita, per incarico di Ludovico II Torres, arcivescovo di Monreale, aveva scritto nel 1593(1d) per il seminario di quella città; […] Nelle regole aleggia lo spirito della Compagnia di Gesù. Esse davano l’egemonia al clero, al quale, oltre all’ autorità ieratica, veniva aggiunta quella della scuola; […]. “Le regole che il Capizzi scrisse per il suo Istituto sono il frutto della sua lunga esperienza. Quelle riguardanti gli studi hanno, in gran parte, addentellato con le regole che il padre Fazio gesuita, per incarico di Ludovico II Torres, arcivescovo di Monreale, aveva scritto nel 1593(1d) per il seminario di quella città; […] Nelle regole aleggia lo spirito della Compagnia di Gesù. Esse davano l’egemonia al clero, al quale, oltre all’ autorità ieratica, veniva aggiunta quella della scuola; […].
“Nell’introduzione a esse regole si parla delle norme per la elezione del direttore, dei deputati, dei visitatori auricolari, dello stipendio dei maestri […]. Le altre onze 100 dell’assegno regio erano destinate per libri, premi per gli scolari e per la manutenzione dell’ Istituto. “La prima parte delle regole riguarda i convittori, la seconda tutti gli scolari. […]
In queste norme si nota lo spirito acuto e pratico del Capizzi, e mostrano com’egli fosse molto saputo delle cose del mondo e della giovinezza. […] Degne di nota le frequenti e improvvise ispezioni del Rettore nelle scuole. […]
Ai convittori incombeva la pulizia delle proprie cose, il farsi e disfarsi il letto, spazzare a turno la camera; […] allora si avvezzavano alla vita. In questo le regole erano conformi alle costituzioni della compagnia di Gesù […] e alle regole del seminario di Monreale. […] “La seconda parte riguarda gli obblighi degli scolari e dei maestri. […] non parlo naturalmente di tutti gli atti di pietà e di religione che informavano la vita dei convittori e degli esterni. Alcune […] norme hanno ora perduto la loro ragion d’ essere; il venerando vecchio, se fosse vissuto ai nostri tempi, avrebbe già adattate le regole alle nuove idee, ai nuovi bisogni(1e). Leggi e istituzioni non durano eterne, mutano coi tempi.[…]   
“Il Capizzi potea bene rallegrarsi dell’opera sua. Ma a tanto uomo, che quasi con regale munificenza, avea aperto al paese una sorgente di ricchezze e di sapere, erano riservate in premio delle amarezze. A lui, come ai grandi cittadini e benefattori, non mancò né l’ ingratitudine né la calunnia, e, che è più, fu ingratitudine e calunnia sacerdotale, la quale egli come era usato portò con allegrezza e cristiana rassegnazione.(1f) […] “Come ultimo pegno di sua devozione alla patria, sborsato un capitale di onze 956, assegnò il Capizzi una rendita sul patrimonio civico della città di Palermo, intestandola al direttore del Collegio. Finalmente nell’agosto del 1783, esausto dalle fatiche, sentendo vicino la sua fine, già predetta da lui tre anni innanzi, volle incassare da sé tutti i suoi libri di valore e li spedì alla biblioteca del Collegio con l’ espresso comandamento ch’essa fosse aperta ad utilità del pubblico.(1g) E all’alba del 27 settembre 1783, giorno di sabato, alle 11 italiane(1h), dopo aver dato l’ultimo pensiero alla patria diletta, lo spirito dell’inutilissimo servo, il San Filippo Neri della Sicilia, come più tardi lo proclamò Pio IX nel processo di sua beatificazione, risaliva ad unirsi cogli spiriti magni della più alta idealità cristiana.”   
“Alla morte del Capizzi […] seguirono altri miracoli. Furono composte canzonette popolari poi musicate e cantate per le vie […] E’ sepolto nella chiesa dell’Olivella […] Una strisciolina di marmo indica la tomba con questa epigrafe: “Hic jacet sacerdos Ignatius Capizzi Congregationis Oratorii contubernalis. Obiit XXVII septembris 1783.”(1i)   
"Il benefico esempio del Capizzi accese in molti il desiderio d’imitarlo. Il fiore della bontà e della beneficenza sbocciò allietando del suo soave profumo le anime. “Donna Maria Scafiti […] nel 1780 otteneva dal Re il permesso di fondare un collegio di Maria […] per l’educazione delle ragazze povere e orfane. […] Nel 1787 la baronessa Papotto lasciava i suoi beni per un reclusorio di Vergini; nel 1793, il dotto e pio arciprete don Placido Dinaro […] assegnava onze 40 all’anno per un istituto di orfanelli e innocenti; e nel 1822, il sac. Pietro Calanna fondava e manteneva del suo due scuole di educazione per le giovanette […]. “Ma torniamo a dir del Collegio. Morto il Capizzi, lasciava egli a maestri, insigni giovani sacerdoti, che, a Monreale, […] erano stati vanto della scuola del Murena, del Miceli, del Caruso, di Nicolò Spedalieri: Carmelo Politi, dottore in filosofia, Francesco Gatto maestro di retorica e valente verseggiatore in latino, Vincenzo Scafiti filosofo, teologo, poeta […]. Lasciava a Rettore e direttore del Collegio il sac. Mariano Scafiti emulo nel sapere al fratello Vincenzo; il sac. Erasmo Spedalieri, Prefetto del cortile e di camera, d’ingegno non minore del fratello Nicolò; Pietro Calanna dottore e maestro di teologia, Saverio Raimondi, maestro di filosofia. […] “Il numero dei convittori intanto cresceva di anno in anno. Alla fine del secolo erano circa 200; e nuove scuole furono create nel 1795; la quarta minore e la quarta maggiore.
Gli alunni brontesi, tornati maestri in patria, adoperarono gli stessi libri, programmi e metodi che a Monreale. […] “[…] non si era usciti dal medio evo. Il latino era la lingua ufficiale della chiesa e della scuola; la sola ritenuta degno strumento d’arte, fondamento e chiave non solo d’ogni disciplina, ma anche dell’italiano.[ …] il Collegio fiorì e divenne, dopo quello di Monreale, uno dei maggiori centri siciliani diffonditori di cultura grammaticale e umanistica per i circostanti paesi dell’Etna e per molti dei Nebrodi e delle Madonie. E la sua fama […] si accrebbe e molti giovani vi attrasse che poi tornarono maestri nella loro patria, o si avviavano a professioni liberali […].
Quuel che fu il nostro Collegio
“Ma quel che fu il nostro Collegio nei suoi primi cinquant’anni di vita, a me piace dirlo con le stesse, sebbene dimesse parole, del Caruso, valente latinista da comparare agli umanisti del secolo XVI, più monrealese che brontese, il quale, nelle notizie per servire alla storia letteraria di Monreale, enfaticamente chiamò Bronte seconda Atene e prima, nel 1780, aveva scritto e pubblicato una elegia latina in lode di illustri brontesi: <Brontis Proposopeja> per cui la piccola terra natale, “non ulli cognita fama” fu nota al mondo intellettuale. […] Diciamolo però sinceramente: erano accademie letterarie senza arte. La cultura era formale e gli studi anche umanistici galvanizzati dallo spirito informatore che aleggiava nella Sicilia e nel continente non erano che vacue esercitazioni.”
Il secolo nuovo
 “Il secolo nuovo metteva intanto negli spiriti desideri e aspirazioni a riforme. Tutti i convitti frateschi, preteschi e governativi non miravano che a istruire la borghesia e la nobiltà; al popolo, ancor timido e servo, non osante aspirare alla vita dello spirito, non pensava nessuno; […]. Anche il nostro Capizzi, sebbene di popolo, e al tempo suo fervesse l’opera di educazione popolare, ideò e volle il suo convitto a immagine e somiglianza di quel di Monreale, […]. Ma i tempi accennavano a mutare.” “Il secolo nuovo metteva intanto negli spiriti desideri e aspirazioni a riforme. Tutti i convitti frateschi, preteschi e governativi non miravano che a istruire la borghesia e la nobiltà; al popolo, ancor timido e servo, non osante aspirare alla vita dello spirito, non pensava nessuno; […]. Anche il nostro Capizzi, sebbene di popolo, e al tempo suo fervesse l’opera di educazione popolare, ideò e volle il suo convitto a immagine e somiglianza di quel di Monreale, […]. Ma i tempi accennavano a mutare.”
Nel 1788 erano state importate dall’Austria in Sicilia le scuole normali, a beneficio del popolo […]. Le prime […] le ebbe Palermo, indi le chiesero ed ebbero molti comuni della Sicilia, applaudite da dotti siciliani e italiani, avversate da altri, specialmente dai nobili, […]. “Il parlamento Siciliano, nel 1815, assegnava alla regia Casa di Bronte perpetuamente onze 200 annue per dette scuole […] e fu mandato a Palermo un prete a spese del Convitto perché vi apprendesse il novello metodo. […] con decreto del 13 maggio 1822 venne soppressa quella antica di leggere e scrivere che in fondo corrispondeva alle due normali. Mancavano intanto delle aule per le scuole e infine le fabbriche in breve tempo furono cominciate e compiute.
“Il Collegio però […] cominciava a declinare. I convittori da 200 che erano sul finire del secolo XVIII ridotti quasi a metà.” E di ciò fu incolpato il Rettore Sanfilippo.   
“Finiva intanto nel 1820 il triennio del Sanfilippo […] e fu eletto il Saitta, il quale però si dimise per non lasciare la cattedra di eloquenza in Monreale, […]. Dopo una breve questione nel 20 giugno veniva eletto il canonico Emanuele Palermo. Il quale ebbe parecchi fastidi per le indebite ingerenze che il comune voleva esercitare sul Collegio […] “Gli avvenimenti del 1820 non scossero punto l’andamento del Collegio, sebbene Bronte, di quei giorni, fosse in piena rivoluzione, […]
“Un grave pericolo turbò la tranquillità degli studi. Nel 1826, il prefetto del cortile sac. Luigi De Luca per 13 anni secondato dal fratello Placido e dal cugino arciprete De Luca, insolentì e diede guerra a maestri e a rettori, sol perché gli si negava il diritto a convivere nell’Istituto, tenendo occupati in questa lotta accanita l’Intendenza e la Commissione Suprema. […] sol nel 1838 il De Luca potè […] essere rimosso dalla carica […] “Coi moti liberali sorti nell’ Isola e nel continente si era venuta svegliando l’assopita coscienza della Nazione. Insieme coi sentimenti di libertà, d’ indipendenza […] s’era pure naturalmente destato il sentimento d’ italianità e con questo l’amore allo studio della lingua che era il legame, il quale univa le varie regioni della patria divisa e oppressa, e che da noi era stato solo nutrimento a pochissimi solitarii.
Ad accendere intanto quel movimento nelle scuole governate da preti e da frati, oltre ai moti suddetti, vi avevano contribuito pure i padri gesuiti con la riforma del 1832. […] In questo fervore di rinnovamento di studi fu gran ventura per il Collegio essere stato eletto il can. Giuseppe Saitta, della cui fama era piena la Sicilia. […] Fino allora l’ insegnamento dell’italiano era tutto nella grammatica […], nell’esposizione dei precetti retorici […] e nella lettura di qualche trecentista. […] Il rettorato del Saitta che durò fino al 2 novembre 1833, quando egli fu eletto vescovo di Patti, segnò un gran passo nella via degli studi. Con lui fecero solenne entrata nelle scuole i classici italiani antichi e moderni. Il piano di studi ch’egli adottò fu quello del 1823 approvato dalla Commissione Suprema. Ma la novità vera che il Saitta portò in Bronte […] fu il metodo […] critico che sostituiva o integrava la fredda analisi filologica […]. Era il metodo umanistico del buon tempo antico […].
Egli intendeva la scuola come più tardi il De Sanctis: un laboratorio dove tutti siano compagni nel lavoro, maestro e discepoli; […] Però non si sa comprendere come con tale sentimento d’arte il Saitta sia rimasto arcade. E vanume arcadico sono i suoi versi […]. Ebbe discepoli valorosi che alla loro volta furono ottimi maestri, e come lui, non lasciarono nulla o poco, oppressi da un inoperoso fatalismo musulmano.   
“Promosso il Saitta a vescovo, i direttori che gli successero non seppero degnamente sostituirlo. […] Declinò l’insegnamento dell’italiano e il metodo umanistico […]; solo nel 1837 colla nomina del Mirenda a direttore fu provveduto a una cattedra di lingua italiana. E, non producendo allora la terra di Bronte maestri atti ad insegnarla, fu invitato il sac. Pietro Paolo Zappalà da Piedimonte Etneo, il quale, stato scolaro del Saitta nel Collegio, vi tornava maestro e in fama di poeta. Per queste novità ed altre non mancarono al Mirenda accuse e ricorsi.
Lo Zappalà non vi durò che un anno e la scuola, a causa della morte improvvisa del Mirenda […] non fu più continuata. Si dolsero i padri di famiglia […] e rimproveri ebbero dalla Commissione Suprema rettori e deputati nel 1840, perché […] lasciavan decadere lo studio dell’italiano. Dopo vari tentativi il (rettore) Tirendi si volse al diacono Vincenzo Leanza, discepolo del Saitta, giovane ventenne, di molto ingegno e di molte speranze, la cui nomina definitiva fu nell’ottobre del 1845. […] Il Tirendi mise su un teatrino […] di giovinetti con repertorio comune […] del tempo per cui grande era la contentezza e ammirazione del pubblico […] Tutto ciò sembrò un gran passo nella via degli studi; l’insegnamento però massimo, assorbente, era il latino […] il poeta piemontese Giuseppe Regaldi […] diceva d’essere passato per Bronte e d’aver visto un grande fabbricato peggiore delle carceri di Randazzo, dove vegetavano nel fetore centoquarantacinque alunni. […] “Duro giudizio e in parte vero! Non sembri ciò irriverente alla mia patria, quando si accenna al sudiciume; ma questo non del solo collegio di Bronte: erano e sono ancora le condizioni generali igieniche di tutto il mezzogiorno e specie della Sicilia, e più dei piccoli centri, ove maggiormente difettava, come a Bronte, l’acqua: giudizio dettato più dal risentimento di non essere stato accolto come egli sperava e meritava, che dalla realtà. […] “Questo stato del Collegio di Bronte era comune a tutti i centri di cultura siciliana, sia per l’indirizzo della politica dei Governanti, sia per la difficoltà dei viaggi terrestri e marittimi. La Sicilia era sequestrata dalla restante Italia, molto più Bronte.
Per avere un’idea delle condizioni intellettuali dell’Isola basta leggere la geniale conferenza di Giorgio Arcoleo, ingegno acuto quanto altri mai: Palermo e la cultura in Sicilia; e Il Tramonto della cultura in Sicilia, dotto saggio dell’ illustre filosofo Prof. Giovanni Gentile, uno dei pochi rappresentanti della cultura siciliana ai nostri giorni.(2a)[…] “Il nostro Istituto, che il Bonghi(2b) in una seduta parlamentare del 1886, chiamò romanamente Foro della lingua latina, lo ripetiamo, fu uno dei migliori istituti classici dove il latino bello ebbe culto e fervore, a cui i vecchi maestri, sebbene ignoranti di critica, di storia e di filosofia, non fallirono mai. Altro che vegetare! Da quel carcere erano usciti eletti giovani che con onore si erano avviati a diversi uffici della vita, a dignità civili ed ecclesiastiche, alle lettere. Ricordo i più noti: il vescovo Giuseppe Saitta […] del quale il cardinale De Luca, suo discepolo, soleva dire: - Di quanti uomini illustri ho conosciuto, niuno ho incontrato superiore al Saitta per altezza d’ingegno e per dottrina varia e profonda -; Arcangelo Spedalieri, Ippocrate(3) siciliano, onore e vanto degli atenei di Bologna e Pavia; Placido De Luca, professore di economia politica all’Università di Napoli e il fratello Antonino, cardinale; l’abate Giuseppe Castiglione, pari del Regno nel 1848, e professore di eloquenza nel Seminario di Palermo; […] Mariano Minissale […] consigliere della Corte di Cassazione in Palermo; […] Luigi Capuana da Mineo, cara e diletta gloria dell’isola nostra;[…].
Questi vecchi e tabaccosi maestri, […] ebbero […] a gloria di avere avuto a discepoli, ai nostri giorni, molti giovani valorosi: fra i quali Carmelo Biuso filologo e filosofo, libero docente in entrambe le discipline, […] i fratelli Cimbali: Enrico, giureconsulto insigne, professore di Diritto civile all’Università di Messina, rapito a 31 anni, alla vigilia d’una plebiscitaria elezione a deputato al Parlamento; Giuseppe, rivendicatore appassionato della gloria di Nicolò Spedalieri, libero docente di filosofia del Diritto all’ Università di Roma […]; Francesco, medico, deputato al Parlamento; Eduardo professore di Diritto internazionale nella R. Università di Catania […]. “Altro dunque che spegnere le care speranze dei giovani etnei! Da quelle prigioni uscirono schiere di giovani avviati pel mondo a prendere ognuno il proprio posto nella vita; da quelle scuole uscirono brigate di giovani brontesi che nel ’48 e nel ’49 difesero Messina pericolante e Catania. Con questo non intendo dire che il Collegio è stato una fabbrica di uomini insigni. Nessuna Scuola, nessuno istituto può aspirare a tanto. Ogni uomo è autodidatta. La scuola informa, avvia. “Dei minori, illustri ignoti dei quali la fama paesana ricorda il sapere e la virtù, si ha notizia nella Storia della città di Bronte di P. Gesualdo De Luca.(4)   
Il paragrafo seguente è la integrazione di quanto si è detto nella monografia che tratta la rivoluzione del ‘48/’49 con la partecipazione che ne ebbe il Collegio di Bronte. 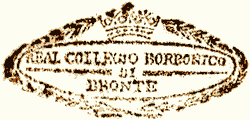 “In quella fregola di innovare, dichiarato decaduto re Ferdinando, a proposta dell’abate Giuseppe Castiglione da Bronte, pari del regno, in odio al Borbone, si volle pure sbattezzare il Collegio […] che prima chiamavasi collegio borbonico, sarà chiamato collegio nazionale(5). […] Ma vi durava sempre la tradizione umanistica. I giovani leggevano gli scrittori latini con […] facilità […]. Solo il latino improntava gli spiriti. Di storia, di geografia, di scienze, di lingue moderne, nulla. Or tali discipline richiedevano i tempi e la rinnovata cultura.(6) “In quella fregola di innovare, dichiarato decaduto re Ferdinando, a proposta dell’abate Giuseppe Castiglione da Bronte, pari del regno, in odio al Borbone, si volle pure sbattezzare il Collegio […] che prima chiamavasi collegio borbonico, sarà chiamato collegio nazionale(5). […] Ma vi durava sempre la tradizione umanistica. I giovani leggevano gli scrittori latini con […] facilità […]. Solo il latino improntava gli spiriti. Di storia, di geografia, di scienze, di lingue moderne, nulla. Or tali discipline richiedevano i tempi e la rinnovata cultura.(6)
Ma mancava l’uomo da ciò. Le regole del Capizzi vietavano, a chiunque non fosse ecclesiastico, il governo del Collegio. Allora, per volere di Pio IX, ospite fuggitivo a Gaeta, interessato da Monsignor Antonino De Luca, vescovo di Aversa, i deputati nel 16 dicembre 1849, elessero a rettore Mons. Giacomo Biuso, protonotario apostolico e prelato domestico del Papa, uomo di varia cultura, che di quel tempo vivevasi in Napoli.
Il Biuso fu tutto a ripulire, rassettare, ordinare il Collegio, e dargli un aspetto di salubrità […], e intanto prudentemente andava maturando la vagheggiata riforma, irta di non poche difficoltà, per via del clero che non voleva essere messo da parte, e del quale non poteva valersi, perché incapace all’insegnamento di novelle discipline. Propose il Biuso altre cinque cattedre […]. I deputati gli diedero facoltà d’invitare dall’Italia i migliori professori. Il Biuso propose anche riforme di carattere organizzativo che gli misero contro il Tirendi, i vecchi maestri e i convittori con i loro padri, onde egli nel gennaio 1851 scriveva dolente a Mons. Crispi “che il collegio sebbene florido di 400 discenti era paralitico per l’insegnamento e la riforma offriva difficoltà molte per l’intrigo dei preti, […] che la deputazione vuole condurre a porto la vagheggiata riforma ma chiede aiuto dal re per mettersi a coperto delle persecuzioni sacerdotali; […] Intanto erano scoppiati anche dissidi interni, sempre perché “soffiava lo spirito mefistofelico del vicario Tirendi,” che spinsero il Battaglia a lasciare il Collegio e provocarono l’espulsione di due giovani che avevano congiurato contro lo Schilirò. Altri problemi ebbe il Biuso con l’Intendente di Catania che “pretendeva che ogni anno si dovesse rendere a lui i conti del convitto, mentre nel concordato del 4 giugno 1844 tra il re e papa Gregorio XVI, […] stabilivasi che il Collegio doveasi governare colle regole del fondatore. […] Il luogotenente generale Satriano però di accordo col procuratore generale del re, stabilirono che i conti del Collegio borbonico(7) di Bronte fossero resi alla Gran Corte.
Cotesti impacci e tramenii interni ed esterni, codeste sorde turbolenze disanimarono e determinarono il Biuso […] a dare le sue dimissioni, respinte con la concessione di due mesi di congedo per ragioni di salute, nel qual tempo la direzione fu affidata al sac. Rizzo. “Nel 14 ottobre 1851 la deputazione eleggeva […] il padre Gesualdo De Luca(8) a professore di diritto canonico e a vice rettore il sac. Rizzo Gaetano. […]
“Nel novembre del 1851 fu inaugurato l’anno scolastico […] alla presenza di Mons. Antonino De Luca, vescovo di Aversa, sostenitore della riforma […] e questo, diciamo, trionfo del Biuso, ruppe il sonno al vicario Tirendi il quale, però, non si diè per vinto. Egli gran maestro di raggiri, fa il suo piano strategico e comincia a dare nuova battaglia al Biuso […] Seminatore di discordie, nulla lascia intentato […] Ma tutte le sue impudiche menzogne sfata il giudice di Bronte Ferlazzo Gasparo, scrivendo alle autorità che al Biuso devesi il rifiorire degli studi e la fama migliore venuta al Collegio. Il Biuso resiste egregiamente, e a confusione dei suoi nemici e ad emulazione dei giovani volle […] rendere pubblico il profitto loro e ne diè alle stampe il resoconto. Questa relazione è il miglior documento morale e intellettuale della mente direttrice del Biuso. L’emulazione, la lode, ora morte nelle nostre scuole, erano la molla che metteva in moto e i giovani e i maestri;[…] Dissertazioni letterarie, filosofiche, canoniche li addestravano al parlare al pubblico; le migliori venivano date alle stampe.(9) […] “Luigi Capuana, ricordando con piacere gli anni passati colà, mi raccontava una sera del 1910 a Palermo, che lì, in collegio, gli cominciò la febbre dello scrivere. A 10 o 12 anni commise un delitto tragico e il corpo del reato fu conservato in biblioteca. […] Divenuto celebre il Capuana donò alla Biblioteca del Collegio un esemplare del suo lavoro: Teatro contemporaneo, con la seguente dedica: Al Collegio in compenso delle mie scappatelle; ed ora […] attendiamo i suoi Ricordi d’infanzia e di giovinezza. “Spesso convertivasi in accademia giovanile anche il refettorio, ove […] risuonava un’elegia o […] un’ode […].
Era tutta produzione agiografica; e per certi rispetti s’era ancora nel Medio Evo. Il rettorato del Biuso […] segnò, possiamo dire, l’epoca d’ oro del Collegio. […]” Finito il triennio il Biuso restò in carica solo un altro anno per le pressioni dei padri di famiglia e l’unanime richiesta dei deputati.   
“Al Biuso successe il sacerdote Rizzo la cui elezione venne di molto contrastata dai visitatori, o meglio dal Tirendi. […] Il Collegio continuò a mantenere la fama acquistatagli dal Biuso. Il numero dei convittori andò giù a 200, di che incolpavasi il dispotismo del rettore; quando le cause credo debban cercarsi nelle sorde agitazioni del decennio. Si avvicinava intanto l’anno fortunoso del 1860, l’anno della nostra redenzione. La rivoluzione, che aveva già pervaso l’ animo dei Siciliani, penetrò anche in Collegio(10) […] “Breve e turbolento rettorato ebbe il Calaciura […] cacciato da una sommossa giovanile […]. Gli successe il sac. Di Bella il cui rettorato fu il più lungo, andò fino al 1879. Sotto di lui gli studi continuarono l’ indirizzo dato dal Biuso. […] “Nel 1862 intanto il prof. Angelo Maiorana, Ispettore e Provveditore agli Studi, manifestò il disegno di trasformare il Collegio in Convitto Nazionale, ma il clero, che ha creduto sempre di avere se non la proprietà assoluta, il dominio utile del Collegio, sorse come un solo uomo, temendo di perdere il monopolio dell’ insegnamento. Il nuovo governo però gli tolse l’amministrazione dei beni e l’assegno annuo regio delle 400 onze; ma […] mantennero al Collegio la sua autonomia, assoggettandolo in quanto agli studi alle leggi dello Stato. Il ministero della Pubblica Istruzione e il Consiglio di Stato nel 1864 […] dichiararono laicale il Collegio e promisero di cooperare al suo miglioramento; e […] nel 1866 gli restituirono l’amministrazione dei beni distratti. “Il rettore Di Bella comprese bene che le istituzioni, se vogliono vivere, conviene che mutino e si evolvano coi tempi; onde, contrariamente alla volontà del clero, e in ciò è da ammirarsi, curò di dare maggiore stabilità alle scuole, facendo dichiarare pareggiato il ginnasio (decreto 22 novembre 1867). […] In quello stesso anno volle il Di Bella dotare le scuole di altre due discipline: le scienze naturali, il cui insegnamento commise al dottor Antonino Cimbali, e la filosofia del diritto, all’avv. Giuseppe Liuzzo, oratore facondo: ambedue i più colti uomini laici del paese. Fra gli uomini colti in quel tempo era anche venuto in istima il D. Luigi Saitta che professava omeopatia.
Ebbe il Di Bella devozione e culto agli uomini insigni di Bronte, dei quali curò eternare la memoria facendone dipingere l’effigie al pittore Agostino Attinà brontese. “Accanto alla scuola pubblica del Collegio fioriva di quei giorni la piccola scuola privata dell’arciprete Salvatore Politi che, avuta dal governo borbonico la patente di maestro insegnava ai giovani non per lucro, ma per amore e per consolarsi(11) […] |  Il sac. Giuseppe Di Bella, rettore del Collegio per 18 anni (dal 1872 al 1879). La scritta in calce al quadro così recita: Il sac. Giuseppe Di Bella, rettore del Collegio per 18 anni (dal 1872 al 1879). La scritta in calce al quadro così recita:
"Archipresbiter Joseph Di Bella, ingenio, doctrina, pietate ac prudentia laudem emeruit Collegium Capizzi XVIII annos solertiter rexit, ac in eo mathescos at litteras latinas egregie docuit. (...)" |
1929: La festa per i 150 anni del Collegio
|
|