| ||||||||||
Antonino Saverio De Luca Nunzio Apostolico a Vienna alla corte di Francesco Giuseppe
Cardinale, fratello dell’economista Placido, fu Nunzio apostolico di papa Gregorio XVI e di Pio IX presso la Corte di Baviera e poi a Vienna, nonché apprezzato autore di opere storiche e di teologia. Si formò negli ambienti ecclesiastici della Sicilia tra Bronte, Monreale e Palermo, distinguendosi particolarmente nell’apprendimento delle lingue classiche e moderne e nello studio delle scienze. Iniziò gli studi a Bronte nel Real Collegio Capizzi, per proseguirli nel 1816 a Monreale, dove, cosa insolita a quei tempi, imparò, oltre al greco ed al latino, anche le lingue inglese, francese e tedesca. Preparava inconsciamente, quasi presagendo, la sua futura carriera di diplomatico pontificio. Ancora ventenne, fu giudicato il migliore nel latino, nel greco, nell’italiano e nella storia sacra e siciliana fra tredici giovani siciliani vincendo, fra l'ammirazione di tutti, mille scudi in un prestigioso concorso. Nel 1827, a ventidue anni, lasciata la Sicilia si trasferì a Napoli e due anni dopo (dicembre del 1829) a Roma dove, dopo un iniziale periodo di stenti, riuscì a pubblicare i suoi primi saggi teologici ed i primi articoli. Scrive di lui Benedetto Radice che per emergere "in quel mare magnum della città universale aveva dovuto servirsi più di remi che delle vele, per poter affermare con legittimo orgoglio: che la maggior gloria di un uomo è quella di dovere tutto a sè stesso quel poco che egli è". ("Due glorie siciliane - I fratelli De Luca", Bronte, Stabilimento Tipografico Sociale, 1926)
All’età di trenta anni, fonda a Roma nel 1835 la prestigiosa rivista bimestrale "Annali delle scienze religiose", che curò e diresse personalmente nel primo decennio. «Collaboravano col De-Luca in questo periodico - scriveva nel 1883 Gesualdo De Luca nella sua Storia della Città di Bronte - i primi letterati di Roma, ed il tutto veniva ordinato con raro giudizio, squisito gusto e con civili convenienze sociali. Di mano in mano vi inseriva il De-Luca suoi articoli originali, ed in ciascun fascicolo si osserva un grande e giudizioso lavoro nell’ordinamentodi tutte le materie.
Egli la crea nel 1835, ed una folla di eruditi lo sostiene ed affianca nell'ardua impresa. Basti citare fra i collaboratori il filosofo Rosmini ed il celebre astronomo Padre Secchi. Un coro di lodi si levo da ogni angolo di Europa: e i suoi Annali di Scienze Religiose fecero conoscere il piccolo abate direttore fin nelle lontane Americhe. Dalla Francia, Ozanam gli scriveva: Voi siete nella cristianità il modello del giornalismo cattolico. E Montalembert: Voi siete il centro di tutto il movimento scientifico di Roma. Il 10 febbraio del 1839, all'età di trentatrè anni, riceve l’ordinazione sacerdotale dal patriarca di Antiochia Antonio Piatti nella sua cappella privata di Roma. Un anno dopo l’Università cattolica di Lovanio nel Belgio gli conferisce la laurea in sacra teologia ad honorem, accordata quasi contemporaneamente al celebre P. Lacordaire. Innumerevoli, delicati ed importanti i riconoscimenti e gli incarichi che ebbe il De Luca (vedi riquadro sotto, a destra). Fu un uomo di chiesa eclettico, coltissimo e strenuo difensore del potere temporale del Papa; fondatore di comunità religiose, membro di Commissioni regie, aggregato a numerose Accademie (la Tiberina, l'Arcadia con il nome di Polinesto Chersoneso, l'Archeologica, la Gioieni di Catania), direttore di periodici, "Professore Coadiutore di fisica sagra nell’Archiginnasio Romano", Vescovo di Aversa, arcivescovo di Tarso, ma soprattutto fu un valente ed abile diplomatico. Nel 1840, nominato censore dell’Accademia di religione cattolica, rettore del Collegio Irlandese di Roma e corrispondente per gli studi storici del ministero della P. I. di Francia, l’Università cattolica di Lovanio (Belgio) gli conferì la laurea honoris causa in sacra teologia insieme al Lacordaire e da Parigi il filosofo Victor Cousin, il fondatore della storiografia filosofica francese, gli comunicava di averlo nominato corrispondente del ministero della Pubblica Istruzione "pour les travaux historiques" (6 maggio 1840). | ||||||||||
| ||||||||||
Durante questo periodo ritornò a Bronte. Consacrò l'altare della cappella interna del Real Collegio Capizzi (dove da bambino era stato chierichetto e dove aveva iniziato gli studi), e per fare un omaggio alla zia abbadessa del monastero di Santa Scolastica, anche la chiesa di S. Silvestro annessa al monastero il 31 ottobre 1851. Qualcuno ancora narra che qualcosa andò storto e non venne trattato bene, tanto che quando andò via, arrivato allo "Scialandro" fece fermare la carrozza, scese, si tolse le scarpe e le sbattè ben forte a terra a ritmo martellante perchè nemmeno un granello di polvere del suo paese lo seguisse; e tanto doveva essere la sua rabbia che spolverando le scarpe ebbe a pronunciare la storica frase: «Gens iniqua, gens rea, non videbunt ossa mea». Ed arrivato a Roma pensò subito a costruirsi un mausoleo. In Aversa il cardinale rimase otto anni. Scrive il Margaglio che "la sua corte vescovile accolse poeti e letterati, tanto che Basilio Puoti si augurava che altri vescovi fossero, come lui, promotori delle lettere". Vi svolse sopratutto un’intensa attività pastorale: fonda un secondo seminario e un convitto, istituisce conferenze settimanali di teologia morale nella cattedrale e in altri luoghi della diocesi, appronta un regolamento per i cimiteri ed una minuziosa registrazione, frutto di una visita da lui fatta nel 1848 nella diocesi, di tutte le istituzioni ecclesiastiche, delle loro origini e condizioni. Una preziosa raccolta di documenti ed iscrizioni (tre volumi manoscritti esistenti presso l’Archivio storico diocesano) ricchissima di notizie - finanche su costruzioni, suppellettili, stati di anime ecc. - che ha fatto la fortuna storiografica di Gaetano Parente, costituendo una delle maggiori fonti cui lo storico di Aversa attinse per la compilazione dei suoi volumi. Promosso arcivescovo di Tarso, il 22 dicembre 1853, il De Luca lascia Aversa. La sua competenza in materia giuridica e le sue capacità diplomatiche e di negoziazione sono premiate con l'avvio di una prestigiosa attività diplomatica.
A Monaco e Vienna il Cardinale, abile negoziatore dallo spirito moderato proprio degli uomini di cultura, cura la stesura e porta a compimento concordati tra i due regni e la Santa Sede e riceve prestigiose onorificenze. A Vienna rimase per sette anni, fino a quando nel Concistorio del 16 Marzo 1863 fu nominato cardinale e rientrò a Roma. Scrive Benedetto Radice che "Pio IX volle premiare l'operosità diplomatica, la dottrina del Nunzio De Luca e la sua fede nei destini del Papato, innalzandolo al cardinalato". Gli mandò lo zucchetto rosso a Vienna, ove il De Luca rimase come Pronunzio fino all'arrivo del suo successore. Fu oltremodo caro al Metternich, all'imperatore Francesco Giuseppe che nel 13 maggio, con solenne cerimonia volle mettere sul capo del Nunzio la berretta cardinalizia e gli conferì la Gran Croce di Santo Stefano d'Ungheria, onorificenza solita darsi a sovrani, a principi reali e ai primi ministri. Lasciata la nunziatura e rientrato a Roma ebbe ulteriori prove di stima e compiti onorevoli e delicati nella Corte pontificia: il 28 dicembre 1864 fu nominato prefetto della Congregazione dell’Indice e, da papa Leone XIII, vice Cancelliere di S. R. C.. L’anno dopo venne cointeressato alla fondazione dell’Accademia di S. Tommaso e nel 1880 fu insieme con altri due cardinali incaricato di preparare l’opera omnia del Dottore Angelico. Al concilio Vaticano I (1869-1870), fu uno dei cardinali incaricati di alternarsi alla presidenza dell’assemblea conciliare. Nel conclave successivo alla morte di Pio IX (1878) fu considerato un Papa mancato. Fra le sue molte opere restarono famosi gli "Annali delle scienze religiose" (una rivista religiosa internazionale dedicata ai cultori delle scienze religiose), che fondò a Roma nel 1835 e che diresse, collaborandovi, per oltre dieci anni. Studioso insigne pubblicò numerose opere di cultura religiosa e storica mentre lasciò
inedita la sua opera principale "Vicende politiche e religiose della Irlanda dal 1536 al 1829". | ||||||||||
| ||||||||||
Antonino Saverio De Luca morì a Roma all'età di 78 anni il 29 Dicembre del 1883, nel suo appartamento al palazzo della Cancelleria vaticana. «La notizia della sua morte - continua p. Gesualdo - recò gran dispiacere non solo ai compatriotti e parenti, sì eziandio a quanti in Italia, per tutta Europa, ed oltre ne conoscevano i grandi meriti. In Bronte gliene furono celebrate l’esequie nel dì terzo per moto spontaneo dell’Arciprete Parroco e del Clero. Al trigesimo i n modo abbastanza solenne si rinnovarono l’esequie, concorrendovi tutti gli ordini del paese in pubblico corteo funebre. Recitata da me, n’è pubblicata l’orazione laudativa con la descrizione dei funerali. La chiesa Cattedrale di Palestrina rese nel dì trigesimo magnifiche onoranze funebri al suo Cardinale Vescovo De-Luca, e non povere dimostrazioni di affetto gli furono fatte nelle cattedrali di Firenze, di Catania e di altre città. Tutti i Periodici Cattolici di Sicilia, d’Italia, del Belgio, dell’Austria, di Francia e di altre nazioni ne annunziarono la morte con amplissime lodi.» Due mesi prima della morte del De Luca, il 27 settembre 1883, ricorreva il I° Centenario della morte del Ven. Ignazio Capizzi. Il Cardinale, sebbene infermo nel suo letto di dolore, con un breve scritto invitava Enrico Cimbali a rappresentarlo presso i brontesi per l’occasione: «Dite ai nostri, che io partecipo col cuore alla festa in onore del Capizzi. La mia vita volge al tramonto, ma, in questo supremo istante, mi è dolce conforto sentire che non si è spenta, del tutto, la sacra fiamma della grandezza del mio paese e la fede nei suoi alti destini… ». Antonino Saverio De Luca fu sepolto nel Cimitero del Verano. Trentuno anni dopo, la salma fu riesumata e traslata, definitivamente, nella Basilica di San Lorenzo in Damaso, nella quale il De Luca era stato Commendatario, dove, accanto alla tomba di Pellegrino Rossi, il Cardinale, ancora vivente, spendendo venticinquemila lire, si era fatto innalzare un fastoso mausoleo, opera dello scultore siciliano Giuseppe Prinzi. |
 Antonino Saverio De Luca, nacque a Bronte da Vincenzo e Francesca Saitta, ultimo di dieci figli, il 28 Ottobre 1805. Fu battezzato nello stesso giorno da don Saverio Raimondo nella chiesa della SS. Trinità.
Antonino Saverio De Luca, nacque a Bronte da Vincenzo e Francesca Saitta, ultimo di dieci figli, il 28 Ottobre 1805. Fu battezzato nello stesso giorno da don Saverio Raimondo nella chiesa della SS. Trinità. Questo celebre periodico interessò tutti i giornalisti delle più colte nazioni dell’Europa per avere prestato gran servizio alle scienze sacre, ed il De-Luca si attiro l’ammirazione e l’amore dei dotti.»
Questo celebre periodico interessò tutti i giornalisti delle più colte nazioni dell’Europa per avere prestato gran servizio alle scienze sacre, ed il De-Luca si attiro l’ammirazione e l’amore dei dotti.»




 Papa Gregorio XVI lo nominò Consultore delle Congregazioni di Propaganda e dell’Indice, professore dell’Università di Roma, direttore della tipografia poliglotta di Propaganda Fide e, appena sei anni dopo l'ordinazione sacerdotale, l’8 dicembre 1845, su suggerimento anche di Ferdinando II, Vescovo di Aversa ed assistente al soglio pontificio.
Papa Gregorio XVI lo nominò Consultore delle Congregazioni di Propaganda e dell’Indice, professore dell’Università di Roma, direttore della tipografia poliglotta di Propaganda Fide e, appena sei anni dopo l'ordinazione sacerdotale, l’8 dicembre 1845, su suggerimento anche di Ferdinando II, Vescovo di Aversa ed assistente al soglio pontificio. Dal 1853 al 1863 Pio IX gli affidò delicati incarichi presso le Corti imperiali di Monaco di Baviera (dal dicembre del 1853, per due anni) e di Vienna (9 settembre 1856, dove fu nominato Nunzio Apostolico), e importanti missioni in Ungheria e Romania.
Dal 1853 al 1863 Pio IX gli affidò delicati incarichi presso le Corti imperiali di Monaco di Baviera (dal dicembre del 1853, per due anni) e di Vienna (9 settembre 1856, dove fu nominato Nunzio Apostolico), e importanti missioni in Ungheria e Romania.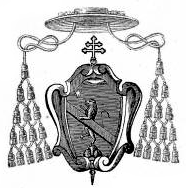 Incarichi ricoperti
Incarichi ricoperti Ordinato sacerdote (a 33 anni il 10 febbraio 1839)
Ordinato sacerdote (a 33 anni il 10 febbraio 1839) - Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Reale di Santo Stefano d'Ungheria (Impero austriaco), l'onorificenza istituita nel 1764 dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria
- Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Reale di Santo Stefano d'Ungheria (Impero austriaco), l'onorificenza istituita nel 1764 dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria








 Fra le innumerevoli opere del card. De Luca, una (la “Storia religiosa e politica d’Irlanda”), all’epoca tanto attesa dall’ambiente religioso e dagli studiosi d’oltre manica, non vide mai la luce.
Fra le innumerevoli opere del card. De Luca, una (la “Storia religiosa e politica d’Irlanda”), all’epoca tanto attesa dall’ambiente religioso e dagli studiosi d’oltre manica, non vide mai la luce. Abbiamo a Bronte la raccolta completa degli "
Abbiamo a Bronte la raccolta completa degli " ’impegno e l’intensa attività pastorale di vescovo di Aversa (dal 1845) costrinsero il cardinale ad interrompere la produzione di saggi e anche l’attività pubblicistica per gli "Annali di scienze religiose", che furono affidati alla direzione di G. Arrighi fino al 1854, anno in cui la pubblicazione cessò.
’impegno e l’intensa attività pastorale di vescovo di Aversa (dal 1845) costrinsero il cardinale ad interrompere la produzione di saggi e anche l’attività pubblicistica per gli "Annali di scienze religiose", che furono affidati alla direzione di G. Arrighi fino al 1854, anno in cui la pubblicazione cessò.