 Nell’archivio storico annesso alla biblioteca del Real Collegio Capizzi sono custoditi alcune interessanti raccolte documentarie, intere annate di quotidiani e periodici di fine ottocento/inizi novecento, finemente rilegati e in perfetto stato di conservazione, ed un settore particolare costituito da libri, testi e documenti di scrittori brontesi. Nell’archivio storico annesso alla biblioteca del Real Collegio Capizzi sono custoditi alcune interessanti raccolte documentarie, intere annate di quotidiani e periodici di fine ottocento/inizi novecento, finemente rilegati e in perfetto stato di conservazione, ed un settore particolare costituito da libri, testi e documenti di scrittori brontesi.
Di particolare rilievo quelli un tempo appartenuti al card. Antonino-Saverio De Luca, nunzio apostolico a Vienna durante l’epoca di Pio IX; quelli del “fondo Cimbali”, ricchissimo di carte e manoscritti, tra gli altri anche di Giuseppe Cimbali, e libri e documenti di Benedetto Radice.
Accanto ai registri che seguono l’attività amministrativa e scolastica dello storico Convitto, viene conservata anche una preziosa raccolta di carte della Vicaria Foranea di Bronte e di una Corte Spirituale operante in città nel corso del secolo XVIII. Esistono poi raccolte minori di eruditi locali e una carpetta segnata con la generica intestazione “Nicola Spedalieri” contenente carte scritte dal filosofo brontese
. Il giovane Nicola Spedalieri, in questo suo primo impegno letterario e apologetico, elaborava un ciclo di sermoni quaresimali, undici orazioni con i quali si misurava con i temi che saranno peculiari della sua riflessione matura. I manoscritti, consegnati al sacerdote concittadino Carmelo Politi, non furono mai dati alle stampe. Quando il Politi da Monreale si trasferì a Bronte, chiamato ad insegnare nel novello istituto fondato da Ignazio Capizzi, gli scritti dello Spedalieri finirono dimenticati in una carpetta e coperti da un velo di silenzio. Nel 1996, dopo oltre due secoli dalla loro stesura, sono stati oggetto di particolare attenzione di un studioso brontese, allora giovane professore di Filosofia e Storia nel locale Liceo, Vincenzo Pappalardo, che ne ha curato la pubblicazione in un volume dal titolo “Quaresimale”. Dal libro, edito dal Comune di Bronte nel secondo centenario della morte del filosofo, abbiamo estratto alcune pagine che di seguito vi proponiamo.
Quaresimale
di Nicola Spedalieri, a cura di Vincenzo Pappalardo 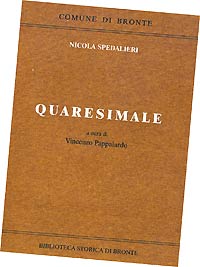 «Nella carpetta segnata con la generica intestazione “Nicola Spedalieri” - scrive Pappalardo nella parte introduttiva - sono contenuti 184 fogli in quarto, fittamente stesi da una mano che conserva la stessa calligrafia minuta, riuniti in parziali legature e sistemati in un ordine che non impedisce qualche grave confusione. […] «Nella carpetta segnata con la generica intestazione “Nicola Spedalieri” - scrive Pappalardo nella parte introduttiva - sono contenuti 184 fogli in quarto, fittamente stesi da una mano che conserva la stessa calligrafia minuta, riuniti in parziali legature e sistemati in un ordine che non impedisce qualche grave confusione. […]
L’argomento dei manoscritti è di carattere omiletico e l’intera raccolta costituisce un Quaresimale composto di undici prediche da recitare in altrettante specifiche giornate del periodo penitenziale che precede la Pasqua.
L’attribuzione di queste carte è agevole: le prediche numero due e numero tre portano in calce all’ultimo foglio l’esplicita e leggibile firma di Niccolò Spitaleri, lectio originale del nome e cognome che il futuro apologeta cattolico, trasferitosi a Roma ed entrato in contatto con ambienti arcadici, ingentilirà nel più classicheggiante ed eufonico Nicola Spedalieri. Tutte le altre prediche non appaiono firmate, ma è facile fugare ogni dubbio sull’autenticità facendo appello all’uniformità calligrafica, alla coerenza complessiva della raccolta, all’esistenza di numerosi spunti che trovano spazio in altre opere dello scrittore siciliano. Ci troviamo dunque con certezza in presenza di quel Quaresimale scritto in età giovanile dallo Spedalieri e documentato sia nelle Memorie sul seminario di Monreale di Biagio Caruso(1), che nell’opera più celebre e approfondita di Domenico Scinà(2), quando si fa accenno, in modo fugace e incidentale alla composizione di una raccolta spedaleriana di prediche quaresimali, stese in un periodo imprecisato ma collocabile negli anni che vanno dal 1765, anno della probabile ordinazione, al 1773-4, epoca del definitivo trasferimento a Roma del giovane docente monrealese. Trascorsi i primi decenni dell’Ottocento sulle omelie quaresimali dello Spedalieri cala un velo di silenzio, che neppure l’effimero rifiorire di studi spedaleriani di fine secolo riuscirà a sollevare. Così, il Quaresimale, pur essendo con ogni probabilità il primo impegno letterario e apologetico dello Spedalieri, finì di fatto con lo smarrirsi e nessuno degli studiosi che in seguito si occuperanno del suo autore si darà la preoccupazione di approfondirne il destino. Dopo un secolo e mezzo di oscurità i manoscritti spedaleriani fanno la loro ricomparsa nella biblioteca del Collegio, lasciando una inequivocabile traccia nella numerazione a cifre romane posta sul foglio d’apertura di ciascun sermone dal professor Francesco Longhitano Ferrau, che tenne la responsabilità del patrimonio librario ed archivistico del Collegio dal secondo dopoguerra ai primi anni ‘80 […]. In assenza di qualsiasi riferimento letterario, il Longhitano risulta comunque essere il primo lettore storicamente riconoscibile delle prediche spedaleriane; la sua fu tuttavia una lettura frettolosa e disordinata. Numerando infatti […] le diverse omelie contenute nella carpetta, il vecchio archivista vi riconobbe dodici testi […]. Una lettura più attenta consente, in realtà, di riconoscere solo undici lunghe orazioni […]; dato l’indubitabile carattere quaresimale dei sermoni, la collezione di carte in nostro possesso è dunque con certezza incompleta. Resta da capire se a noi sono giunte solo alcune delle omelie scritte dall’apologeta brontese del Settecento, o se lo stesso autore lasciò ad un certo punto interrotta la fatica. In mancanza di una qualsiasi testimonianza storica il dilemma rischia di rimanere insoluto; vi sono tuttavia elementi a favore dell’una e dell’altra ipotesi. L’ordine dei sermoni sembra infatti seguire un criterio giornaliero, avendo inizio con il mercoledì delle Ceneri e proseguendo quasi ininterrottamente per la prima settimana della Quaresima, fino al martedì della seconda settimana: è probabile dunque che l’autore abbia lavorato con sistematicità al suo progetto, fino a quando un calo di tensione e l’emergere di altri interessi non l’abbiano distolto e indirizzato verso altri impegni. Alcuni elementi formali confermano questa ipotesi: la pulizia e la correttezza degli scritti subiscono un andamento visibilmente decrescente e dal rigore delle prime e più vecchie omelie si passa ad un disordine gradatamente più accentuato nei testi più recenti, nei quali compaiono numerose correzioni e per i quali manca una riscrittura definitiva che diremmo in bella copia. A sostegno dell’ipotesi contraria stanno invece gli spazi che interrompono la continuità temporale del periodo quaresimale. Mancano infatti i sermoni del martedì e sabato della prima settimana, nonché quello della seconda domenica: se il nostro autore avesse seguito un piano sistematico, avrebbe dovuto stendere quelle omelie che oggi mancano. Del resto l’ordine sparso in cui si trovano alcune carte della collezione sopravvissuta confermerebbe una certa incuria, alimentando respiro al sospetto che una parte delle carte potrebbe essersi smarrita. In definitiva, gli elementi in nostro possesso documentano un progressivo distacco dello Spedalieri dalla sua fatica omiletica, comprovato anche dall’abbandono delle carte nelle mani del chierico concittadino Carmelo Politi, mentre resta giustificato il dubbio che almeno una parte della raccolta sia andata col tempo smarrendosi. Gli undici testi in nostro possesso si definiscono dunque come omelie e si collocano in modo preciso nelle singole giornate del primo periodo quaresimale. Con più esattezza, seguendo le indicazioni di giorno che nella maggior parte dei casi sono esplicitamente poste in apice al foglio d’apertura, le prediche restituiteci dall’archivio del Collegio seguono ininterrottamente i giorni che vanno dalle Ceneri al lunedì della “prima settimana”; poi, dopo un vuoto corrispondente al primo martedì, siamo in possesso delle orazioni del mercoledì, giovedì, venerdì della prima settimana; quindi una lacuna di due giorni, e le prediche del lunedì e del martedì della “seconda domenica”. Non sempre i fogli iniziali di ciascuna orazione portano l’indicazione della giornata di recitazione: questo succede per i testi segnati con i numeri I, III, VII, IX. E’ possibile tuttavia risalire agevolmente al giorno pertinente facendo riferimento alla citazione posta nel thema inaugurale di ciascuna omelia, che risulta essere sempre tratta dal vangelo del giorno. I testi segnati con i numeri IV e V recano la medesima indicazione: “nel mercoledì della prima Domenica”. Non si tratta tuttavia di due varianti di una stessa orazione, e la citazione posta nel thema dell’omelia segnata con il numero IV, tratta dal passo di Matteo che narra l’episodio della Cananea, ci conduce in realtà al giorno successivo, il giovedì della prima settimana(4). […] Ben nove delle undici omelie muovono dal commento di passi tratti dal vangelo di Matteo, conferendo all’intera raccolta il carattere unitario di una riflessione ispirata a quel testo sacro; gli altri due sermoni vengono invece introdotti da proposizioni giovannee. Un forte rigore formale caratterizza l’orazione 1, che si è identificata come riflessione della giornata delle Ceneri: ordinata e schematica, priva di correzioni, in elegante calligrafia, è suddivisa in quattordici paragrafi ed è accompagnata da un foglio di chiusura nel quale sono riassunti in quattro punti i nodi fondamentali del sermone e vengono riportate citazioni latine di Agostino e della Lettera a Tito. Mano a mano che la raccolta procede l’attenzione formale si allenta e solo le omelie 2 e 3 contengono una distribuzione in paragrafi, con una divisione rispettivamente in ventiquattro e sedici capoversi; mentre il foglio sparso, erroneamente segnato dal vecchio archivista con l’indicazione X, appare come un abbozzo incompleto di epitome alla omelia 2, dello stesso genere riscontrato per lo scritto 1. Tutti gli altri testi appaiono meno curati sotto il profilo formale, privi degli strumenti di lettura su evidenziati e, a partire dal sermone 5, gravati da correzioni, tagli e aggiunte che lasciano adesso trasparire una maggiore frettolosità, una diminuita attenzione alla leggibilità del testo e, probabilmente, all’intera fatica; è probabile che l’aumento degli impegni didattici e le prime infuocate dispute teologiche abbiano spostato lentamente l’interesse dello Spedalieri verso altri obiettivi, facendo mancare al Quaresimale la cura prima ricevuta e condannandolo, forse, all’incompiutezza. Va rilevato come l’undicesima omelia resti nel suo interno interrotta dallo smarrimento di almeno un foglio. Tutti i testi in nostro possesso recano, nello spazio bianco lasciato a margine di ciascun foglio, numerose annotazioni di carattere bibliografico. Si tratta in genere di indicazioni dei luoghi scritturali o patristici delle citazioni poste nel testo, oppure di estese riprese dei passi accennati nel discorso. Le citazioni di autori cristiani riguardano soprattutto l’epoca patristica, con brani di Tertulliano, Gerolamo e soprattutto Agostino; rare le apparizioni dei Dottori e dello stesso Tommaso. I manoscritti in nostro possesso presentano caratteristiche di grafia e punteggiatura proprie dell’epoca in cui furono scritti, con un’anarchia linguistica inevitabile nella Monreale del Settecento, lontana dai centri del volgare italiano dell’epoca e immersa nella stagione di reviviscenza classica voluta da monsignor Testa nell’ordinamento del suo seminario.(5) Dal punto di vista grafico risaltano le maiuscole che compaiono numerose nel testo; avverbi come perché, poiché, conciossiaché ed altri appaiono privi dell’accento acuto; manca in generale un’uniformità ortografica e per molti termini sono documentate lezioni diverse. La punteggiatura risulta disordinata, mentre l’uso dei due punti e del punto e virgola sembra spesso confondersi, senza evidenziare un ruolo ortografico delineato.
Un secolo e mezzo di oscurità
Dagli sporadici accenni dei primi decenni dell’Ottocento alle tracce che informano sulla presenza delle carte spedaleriane nel collegio di Bronte trascorrono cento trenta anni. Una lunga ombra di silenzio avvolge il destino del Quaresimale, ancora più sconcertante quando si considera lo strano disinteresse di quegli studiosi che con metodicità si interessarono al suo autore. Sul percorso compiuto dalla raccolta di sermoni dopo la partenza per Roma dello Spedalieri abbiamo qualche informazione certa(6): essa entrò in possesso del sacerdote brontese Carmelo Politi, il quale da Monreale si trasferì presto a Bronte come insegnante del novello istituto là fondato da un intraprendente ecclesiastico del luogo, Ignazio Capizzi(7); l’ipotesi più plausibile è che, morendo, il Politi abbia lasciato le sue carte in Collegio, e che tra di esse vi fosse quel Quaresimale che noi, appunto in quella biblioteca, ritroviamo. Naturalmente non è possibile scartare l’ipotesi di un giro più lungo, che vedrebbe le prediche passare di mano e seguire strade misteriose, sinché esse sarebbero giunte in Collegio, magari attraverso qualcuna delle cospicue donazioni librarie e documentarie che in questo secolo hanno visto beneficiaria la biblioteca dell’istituto.(8) Comunque sia andata, è indubitabile che le nostre carte fecero presto il loro ingresso a Bronte, rimanendo circoscritte nell’ambito ristretto dei luoghi e dei personaggi della cultura locale. Stupiscono perciò le omissioni degli studiosi brontesi che si sono in vario modo interessati di storia locale.(9) Particolarmente sospetto appare poi il silenzio di Giuseppe Cimbali, il confuso e velleitario erudito brontese che, nello scorcio del secolo scorso, si fece banditore di un chiassoso progetto di riscoperta dell’illustre concittadino.(10) Nella sua attività di ricerca, il Cimbali, appartenente ad una famiglia di fresco notabilato locale, ebbe agio di visitare la biblioteca del Collegio e di scoprirvi un fondo archivistico all’interno del quale erano custodite lettere dello Spedalieri a familiari e conoscenti(11); nessun cenno viene fatto delle carte quaresimali, che noi oggi ritroviamo nello stesso archivio, l’esistenza delle quali non poteva essere ignota allo stesso Cimbali, che in una occasione si trova a citare il brano di Biagio Caruso nel quale si accenna alla raccolta omiletica(12). Né del resto è altrove documentato l’interesse a rintracciare e recuperare questa interessante e inedita collezione di carte; circostanza tanto più strana se si pensa alla ostinazione di un personaggio altre volte colto a visitare biblioteche pubbliche e private di tutta Italia(13). Si potrebbe allora pensare ad una volontaria omissione da parte di uno studioso come il Cimbali, il quale, impegnato ad accreditare uno Spedalieri campione del pensiero liberale, modernamente laico, per questo addirittura in odio presso gli ambienti filoclericali della sua epoca, avrebbe letto con imbarazzo scritti di carattere pastorale nei quali prende corpo l’immagine di un pensatore senza margini di ambiguità, impegnato nella difesa dommatica e tradizionale della religione con l’utilizzo di argomenti non di rado retrivi; un pensatore volto, soprattutto, al radicamento della centralità dell’istituto ecclesiastico, la cui mediazione si ritiene necessaria ai fini della salvezza ma anche del corretto vivere civile e del mantenimento dell’ordine nello Stato. Del resto, già la lettura de I Diritti dell’Uomo compiuta dal Cimbali, enfatizzando quegli aspetti del pensiero spedaleriano che riportano gli ideali della modernità rivoluzionaria nel tronco essenziale della dottrina evangelica, è costretta a porre una parentesi su quegli aspetti complementari che conferiscono alla Chiesa cattolica il ruolo portante nell’asse dei nuovi equilibri politici affacciatisi all’indomani degli sconvolgimenti francesi.
I caratteri
La diffusione di collezioni di omelie risale sino ai tempi di Carlo Magno, epoca nella quale è già possibile imbattersi in raccolte di prediche quali quella di Rabano Mauro “ad legendum vel ad praedicandum” concepita(14). Sarà però la fatica francescana e domenicana a consolidare la predicazione in genere letterario dallo schema e dalle regole definite; fioriscono così le Artes praedicandi, autentici manuali per la composizione di prediche nei quali vengono codificati i canoni fondamentali del Sermo Modemus, la cui elaborazione gira attorno al thema, il versetto biblico posto all’inizio del testo, e i cui riferimenti scritturali vengono riuniti nelle concordantiae, strumenti fondamentali per la prima volta raccolti a Parigi dal domenicano Hugues de Saint-Cher tra il 1230 e il 1235(15). Il periodo controriformista incide anche sul carattere della predicazione, che ora perde il suo carattere di eccezionalità, spesso di esercizio retorico tra appartenenti ad ordini diversi, entrando tra i compiti ordinari del parroco che in tal modo spiega il vangelo; accanto ad esso però sorgono delle figure ecclesiastiche specializzate, che iniziano a sciamare per le varie chiese europee curando quelle “missioni” che costituiscono una delle componenti più specifiche della religiosità cattolica moderna. Il gesuita Paolo Segneri rappresenta uno dei modelli più celebri e riconosciuti di tale temperie spirituale e culturale. I temi dell’attività predicatoria di questa epoca variano seguendo la dislocazione geografica delle turbolenze religiose, culturali e morali del Seicento e del Settecento. Le zone poste ai confini con le aree di diffusione protestante conoscono così una predicazione catechetica, volta a rafforzare la coscienza cattolica di popolazioni esposte al contatto con ambienti riformati; le omelie gesuite della “Provincia neapolitana” preferivano invece “ ... argomenti morali e cercavano di indurre gli ascoltatori a confessarsi, con argomenti come la mostruosità del peccato, la morte imminente, le pene dell’inferno”(16). Il Quaresimale composto dal giovane Spedalieri negli anni dell’insegnamento monrealese, in un ambiente fortemente intriso di cultura gesuitica(17), riprende il carattere penitenziale della tradizione ignaziana meridionale, immettendosi scolasticamente all’interno di un filone nel quale, se emergono i temi fondamentali della coscienza del tempo - le ingiustizie della società e della economia, lo scetticismo religioso, il razionalismo illuminista - mai tuttavia si riscontra la capacità di penetrare il senso dei profondi mutamenti che interessano il Settecento. Il Quaresimale di Nicola Spedalieri non rivela così l’acutezza dell’interprete consapevole del suo tempo; esso mantiene piuttosto un carattere retorico, esercitazione scolastica in un genere abitualmente frequentato dalla letteratura gesuitica ed ultimamente nobilitato, proprio nel meridione d’Italia, dall’attività intensa ed affascinante di Alfonso de’ Liguori. Ad accentuare l’ispirazione retorica dello scritto vi sono poi le peculiarità della formazione ricevuta dallo Spedalieri nel seminario di Monreale, in un ambiente riscaldato da dispute infuocate, nel quale la ricerca intellettuale si esalta in occasione di agoni dialettici puntualmente organizzati, e nel quale lo stesso Spedalieri ebbe modo di mettersi in mostra in una accesa controversia che oppose lui, monrealese e filogesuita, al benedettino palermitano Evangelista di Blasi; qui lo scrittore brontese maturò quel carattere polemico, controversistico, confutatorio che impresse in molte opere della sua attività romana. Scorrendo le pagine del Quaresimale è allora possibile riscontrare numerose evidenziazioni del carattere retorico che informa lo scritto; proprio qui anzi è possibile individuare le più chiare irruzioni dello Spedalieri nel testo quando, abbandonando la forma apologetica e parenetica del discorrere, l’autore si ferma a compiacersi della sua abilità dialettica, comunicativa: “ ... se io non vi proverò ad evidenza la necessità di questo distacco dalla terra e da tutto ciò che più ci alletta, abbiatemi per un ciarlone, per un ignorante; privatemi dell’onore di poter parlarvi di nuovo in questo luogo; se poi giungerò a convincervene, non tocca a voi pigliare le più giuste risoluzioni?”(18). E non di rado l’accenno alla propria persona diviene enfatico: “Voi Uditori ... non vi mettete in altra pena, che d’ascoltarmi: parlerò io per voi ... e se non bastano ancora gli argomenti son pronto ancora a difenderla col sangue”(19). O ancora: “ ... pensando al Giudizio palpito, fremo, sudo freddo ... ah quale sarà la mia sentenza ... e non debbo spaventarmi, e non mi si debbono arricciare i capelli ...”(20). Il tono retorico dello scritto si rivela nel compiacimento letterario delle immagini, delle descrizioni, nel costante scivolamento verso l’icastico, l’iconico. Il gusto è multiforme, e il futuro Melanzio Alcioneo dei circoli romani dell’Arcadia sceglie ora sfumature tenui, leggere, rappresentando i poveri angariati dai ricchi: “ ... non ci molestate, non c’insidiate quel poco, che ci guadagnamo co’ nostri sudori”; sempre i poveri: “ ... implorano la vostra pietà, aspettano il vostro soccorso; e forse nol meritano? Con quanta reverenza vi stanno davanti, con quanta sottomissione vi parlano ... E quando la morte rapisce loro un di questi Benefattori, infelici come alzan le grida, come si strappano i capegli, come si graffiano il volto, come lo seguono sin al sepolcro!”(21). Le metafore paesaggistiche rendono ancora di più il gusto melenso del Settecento letterario: l’ostinato lontano da Dio è, per esempio, “ ... come un ruscello che distaccato dal materno fonte, si va a perder tra’ sassi; è come un ramo che svelto dal tronco s’inaridisce; è come un figliuolo diseredato e cacciato via dal Padre, che va incontro alla miseria”(22). Accanto a queste atmosfere delicate, arcadiche, convivono però toni forti, addirittura macabri, nei quali l’artificio del predicatore cerca la facile suggestione. A volte l’ombrosità delle tinte cerca di muovere compassione verso i deboli e i poveri: “Mirate que’ cenci ... quelle ruvide e nere carni, quell’ossa spolpate ... quelle mani incallite al travaglio, que’ volti squallidi e minuti ... Voi avvolti tra l’ostro e il bisso, e quest’ignudi!”(23); altre volte la durezza del richiamo carica la forza della scena, come quando si descrive la vita del soldato: “ ... i gemiti, le grida de’ moribondi sono pe’ soldati incentivi di nuove straggi”(24). E’ però nel dipingere le pene dell’inferno, e nella rappresentazione non meno fosca del giorno del Giudizio, che nello Spedalieri alita lo spirito più macabro. Ecco come, nel corso della settima omelia, viene immaginata la resurrezione dei corpi: “ ... tutte le ossa correre ciascuna al suo capo, eccole coverte a poco a poco di pelle, rammmarginate le piaghe, scossa la muffa ...”(25).
Qui emerge però l’aspetto complementare e assolutamente fondamentale della fisionomia letteraria dello scritto spedaleriano: l’uso degli strumenti retorici ha in sé la determinazione di catturare il timore e perciò la fede dell’ascoltatore. Spulciando qua e là nelle pagine del Quaresimale ci si imbatte più volte nella consapevolezza dell’autore circa l’efficacia penitenziale delle immagini più crude: “Basta agli Uomini che si parlasse loro d’Inferno per ascoltarvi colla più bella pace del Mondo ...”(26). Il carattere letterario dello scritto non contraddice insomma la volontà parenetica, religiosa, moralistica della predicazione. Sarebbe dunque sbagliato liquidare queste inedite orazioni sacre spedaleriane come fossero un esercizio puramente retorico, dimenticando le peculiarità di formazione e di professione dell’insegnante in uno dei più prestigiosi luoghi della cultura siciliana del Settecento, e le stesse caratteristiche del seminario monrealese, che la riforma voluta dal nicosiano Francesco Testa aveva indirizzato verso un neoumanesimo retorico e classicheggiante. I due piani, letterario e religioso-parenetico, compongono così un difficile equilibrio che viene alla superficie nelle non rare apparizioni della passione e della partecipazione dell’autore(27). In definitiva, questa esercitazione retorica del giovane Spedalieri, pur rimanendo tale, rappresenta nella cultura umanistica della Monreale dell’epoca l’approccio privilegiato con la sensibilità e con la religiosità, anche popolare, del tempo. […]
Conclusioni
Tra le ambiguità che si sono sottolineate nella logica della discussione dei temi quaresimali si è finora, volutamente, sottaciuta quella che nascerebbe dal primato del cuore sull’intelletto: “ ... non già che la corruzione del cuore proceda dalla cecità dell’Intelletto; ma la cecità dell’Intelletto procede dalla corruzione del cuore”(109).
Qui Spedalieri riprende il tema della impossibilità di una conversione puramente intellettuale; perciò condanna la pretesa degli scettici del tempo: “Povera religione che per essere esaminata si dee prostrare al Tribunale ... di certi Uominicciuoli ridicoli per l’ignoranza, dispregevoli per corruzione de’ costumi ... ; costoro per aver letto qualche Romanzo o Comedia, passandosela la notte in seno alle meretrici, il giorno co’ bricconi osano passare per Uomini dotti”(110). Lo stesso clero ha smarrito l’irreprensibilità dei costumi, il predicatore non lo nasconde, tuttavia “ ... le labra de’ sacerdoti sono le depositarie della scienza divina”(111). La Rivelazione, che Dio media al popolo attraverso la Chiesa, sottrae il clero dal rischio di una visione annebbiata della verità. Il popolo però, corrotto nel cuore e perciò cieco nella ragione, come può accostarsi al cammino penitenziale di un ciclo quaresimale quando le verità del credo cristiano vengono sostenute con gli argomenti dell’intelletto? Bisogna insomma comprendere come conciliare l’istanza apologetica con lo strumento predicatorio, la difesa del credo cristiano con l’intento penitenziale, la ragione con la parenesi. Nella soluzione di questa apparente ambiguità la concezione spedaleriana recupererà una sua unità e una dignità insieme intellettuale e religiosa. Abbiamo già evidenziato come la stesura del Quaresimale presupponga la consapevolezza di alcuni concetti suareziani: l’intelletto ha la capacità di conoscere l’oggetto della Rivelazione; solo la grazia può trasformare questa conoscenza in conversione di fede. Spedalieri sviluppa un ragionamento di questo tipo: con la colpa originale l’uomo ha perso la possibilità di vedere la verità, per ciò Dio ha supplito con la Rivelazione; questo però non pregiudica la razionalità dell’universo e dunque la possibilità che un corretto uso della ragione possa giustificare, con un cammino per così dire a ritroso, la verità rivelata. Così facendo l’abate brontese distingue due usi della ragione: quello illuministico, che ha la pretesa di spingere la ragione verso la ricerca pura, dimenticando come il peccato abbia offuscato la corretta visione dell’intelletto umano; quello religioso, che ammette la conformità della ragione a Dio, ma considerando gli effetti del peccato, delimita lo spazio dell’intelletto incaricandolo della deduzione di argomenti che giustifichino la razionalità delle verità della rivelazione. La filosofia è insomma apologetica, non teoretica. La difesa delle verità cristiane, che la tradizione settecentesca interpreta come riflessione sui fondamenti della teologia, viene assunta dal giovane Spedalieri come l’unica via aperta alla riflessione filosofica dell’uomo.
Questo non spiega ancora il ruolo della ragione apologetica nella specificità di ispirazione e di intenti di un ciclo di sermoni quaresimali, che hanno la ragion d’essere nell’obiettivo di aprire alla penitenza e alla conversione. Come Suarez, anche Spedalieri è convinto che l’intelletto umano resti impotente di fronte a quel salto che è l’abbraccio della fede(112); pur nelle incertezze di una debole teoretica, lo scrittore siciliano evidenzia il ruolo preponderante della grazia, la cui azione appare al nostro meno invisibile che al teologo gesuita, identificandosi in gran parte (eccezionale si rivela il dovere di riprensione dell’amico) con le mediazioni sacramentali e pastorali della Chiesa. Tra queste, lo Spedalieri del Quaresimale e del Fréret sottolinea la radice addirittura evangelica del ministero della predicazione, ai cui effetti Cristo esplicitamente sottomise il raggiungimento della salvezza(113). L’esercizio quaresimale del giovane docente monrealese acquisisce allora una nuova dimensione: oltre alla innegabile fisionomia retorica e scolastica, oltre alla fondamentale ispirazione apologetica, l’attività oratoria del predicatore diventa strumento privilegiato di grazia, canale appositamente scavato da Dio nella sua preoccupazione di raggiungere l’intimità del singolo. La predicazione trasfigura con la forza di un contatto, che però Spedalieri non vede mai come irresistibile, restando sottomesso, pur con qualche ambiguità, ad un atto di volizione, di accettazione individuale della fede.
Così la predica che parla all’intelletto non può non diventare apologia, fondazione della verità della fede nella razionalità dell’ordine voluto da Dio; ma questo non contraddice l’obiettivo parenetico e neppure quello retorico della pratica oratoria, laddove lo strumento letterario serve ad uno scopo educativo e questo apre la via di accesso all’inserzione del divino nell’uomo. In questa prospettiva, il Quaresimale spedaleriano, con tutti i limiti di un argomentare giovanile incerto ed eclettico, assume una unitarietà complessiva nella quale trovano sistemazione, secondo una adesione a temi scolastici abbastanza personale, ispirazioni diverse di carattere retorico, parenetico, apologetico, religioso. L’organizzazione progressiva di questi spunti disparati costituirà, a nostro parere, il senso della fatica intellettuale del periodo romano, quando lo scrittore siciliano irrobustirà il nerbo di una vocazione apologetica, conferendo vigore morale e politico ad un’opera che conoscerà nell’Italia di fine Settecento un rilievo effimero, ma indiscutibile. [...] |