 IL SEMINATORE CHE NON MIETE IL SEMINATORE CHE NON MIETE
Dai principi estetici, esposti dallo Schilirò, a proposito dell'arte d'annunziana, nasce Il seminatore che non miete che «riflette il periodo dell'immane guerra e i primissimi anni del dopo-guerra. Si vorrebbe chiamarlo romanzo o poemetto, a seconda che si guardi alla favola o alla forma; ma a me pare che abbia qualcosa dell'uno e dell'altro. Quello però a cui bisogna dare valore assoluto è proprio la favola. L'opera s'ha da guardare nel complesso dei suoi svariati elementi». La fonte o il motivo ispiratore dell'opera sono I dolori del giovane Werter, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Miranda e il mistero del Poeta. Infatti, «l'amore sfortunato di Massimo per Bianca ci rimena a Werter e Carlotta; l'amore sacrificato sull'altare della patria ci rammenta Jacopo Ortis; l'idillio, sebbene miseramente finito, ci fa pensare a Miranda». Ma, ripeto, nel Seminatore l'interesse non è destato dal racconto che, del resto, è semplicissimo. Massimo, appena laureato in giurisprudenza, lui stoffa di poeta, incontra Bianca, un'anima che lo comprende; se ne invaghisce e si fidanza. Ma scoppia la guerra ed egli si arruola volontario e va a difendere la patria. Viene ferito gravemente e sfregiato orribilmente al volto. Tutto è perduto. Che farà Bianca? Seguita ad amarlo, anche dopo il sacrificio. Infatti quando egli muore, addolorato dalle discordie civili che mettono in pericolo i frutti della vittoria e la sicurezza della patria, per cui Massimo e il suo amico Guidotti hanno immolato la gioventù, ella si vota a una missione di bene e di civiltà. Semplice l'intreccio [...] ma notevolissimo l'effetto estetico, perché la narrazione [...] si anima della grande esperienza del Poeta e ne rende con immediatezza le più vive e delicate impressioni [...] che nascono da due elementi essenziali e inscindibili: l'amore di Massimo per Bianca e l'amore suo per la patria [...] il Poeta, per una virtù di sintesi straordinaria, ha saputo infondere tal soffio a quelle fugaci note, che il lettore vola ad ali spiegate per tutto il campo dell'azione, che è abbastanza vasto. Tutte le gioie delle ore di speranza, le angosce dei giorni tristi, tutta la vita e l'ideale di Massimo stanno nei suoi canti [...] mentre Bianca non si sente, ma compare in scena coi richiami di Massimo: del suo poeta. L'amore della patria: ecco il centro del dramma. Per esso la vita, pur nelle più gravi sventure, diventa bella, perché dal sacrificio e dal dovere compiuto germinerà una vita migliore. Concepita così l'esistenza volge a quell'ottimismo [1] che comincia a guidare la nostra generazione [...] e possiede ormai una letteratura tutta sua. Non ultima, in questa, siede l'opera dello Schilirò. Lo Schilirò volle dare il modesto titolo di Appunti al suo trattato di estetica forse perché [...] egli ne ha parlato in un volume di appena 220 pagine; ma, di fatto, ha addensato più idee che gli altri, e la sua opera è completa. Essa, come abbiamo visto, aveva fatto una prima apparizione ne I motivi estetici dell'arte d'annunziana. [...] In verità essa richiedeva una trattazione a parte: e lo Schilirò, che vi aveva dedicato tutte le forze della sua mente sottile e logica e non aveva risparmiato lavoro e veglie amorose, colse l'occasione del fatto che il Governo, nella riforma scolastica, imponeva nei licei lo studio dell'estetica e pubblicò a principio del 1924 il nuovo libro. [...] fuso è così completo e d'un'armonia dialettica che rapisce. [...] Un profano potrebbe supporre che in tema d'arte il vero competente sia l'artista. Noi diciamo: sì, ma a patto che l'artista sia anche filosofo. «In lui abbiamo l'artista e il filosofo che ha rifatto per conto suo uno dei sistemi più discussi, più complessi, più attuali; l'artista che ci presenta tutta la visione del suo mondo ideale in modo così vivo e limpido».
Il trattato risulta di due parti, di cui la prima comprende alcuni cenni storici del pensiero estetico, la seconda la trattazione personale dei vari problemi. Ci fu chi disse che egli è un crociano, e tra costoro fui io; chi disse che non è crociano per nulla; chi, infine, vide in lui un ammiratore del Croce e, come io stesso allora ammettevo, un rifacitore per conto suo dell'estetica crociana. Oggi mi pare che la vera posizione dello Schilirò l'abbia intravista il Mansion il quale scrisse: «Ses vues personelles trahissent une influence évidente de l'ésthetique de B. Croce; mais, en meme temps, il rejétte de la facon la plus décidèe la philosophie idéaliste à laquelle Croce a rattaché ses vues sur l'art. Dès lors, la conception ésthétique de Vincenzo Schilirò quand bien meme elle parait se rapprocher très fort de celle de Croce par certains còtès, prend une signification totalement différente»[2]. [...] Nel campo della conoscenza c'è un minimo di verità o terreno comune [...] infatti, accettato il principio [...] che nessuna realtà può essere oggetto di conoscenza se non in relazione con l'attività conoscitrice, il fatto artistico deve essere studiato come fenomeno interiore della singola attività spirituale. [...]
L'opera d'arte, intesa come oggetto sensibile, agisce sull'ammiratore e sveglia in lui nuovi atti spirituali e sempre nuovi godimenti estetici. [...]
L'essenza, pertanto, del fenomeno estetico s'immedesima con quella misteriosa e complessa attività creatrice dell' anima umana, che è personale e caratteristica in ciascun individuo, gli atti singoli del quale sono l'uno diverso dall'altro e non si ripetono mai nell'identica forma. Così lo Schilirò determina l'unità e l'individualità di ciascun spirito, ne estende i fenomeni estetici a tutta la serie ininterrotta di atti coscienti che formano «il costante divenire o evolversi o vivere di esso». [...] L'arte si rivela creazione [...] e non può essere contenuta né da generi o classi, né da categorie, ma segue l'ansito misterioso e le vicende molteplici della vita [...] e diventa il linguaggio cosciente di ciascun'anima. [...] L'estetica dello Schilirò si differenzia nettamente da quella del Croce nel precisare l'elemento costitutivo dell'arte, [...] che è per il Croce visione o intuizione, mentre per lo Schilirò, che si basa sull'unità inscindibile dello spirito, è uno stimma o connotato divino. Lo Schilirò fa derivare l'indipendenza esistenziale dell'arte dal suo contenuto, sia logico che morale [...] ma non tutte le opere d'arte sono esempio di castigatezza e di coerenza logica. Perciò «la libertà artistica incontra un limite logico nelle altre forme di attività». [...]
E secondo lo Schilirò il giudizio che critica o analizza un fatto spirituale già verificatosi, è un nuovo atto spirituale che soppianta il primo, ed è quindi la negazione di esso. [...] Critica ed estetica sono termini antitetici. In conclusione per lo Schilirò la critica [...] può avere tre aspetti: o è pura ricreazione, e allora va intesa come rifacimento spirituale dell'opera; o è un lavoro logico a posteriori [...]; o vuole essere aiuto o mezzo per delibare l'arte, e allora riesce una fatica vana, perché il gusto non si insegna né si suggerisce. Egli, perciò, dice ai suoi giovani: «Voi non siete creta da plasmare, né vasi da riempire. Siete anime libere, che vogliono vivere, ciascuna per sé, in perfetta autonomia».
 SANTO FRANCESCO SANTO FRANCESCO
Nel 1926 Vincenzo Schilirò pubblica, sempre a Bronte, per i tipi dello Stabilimento Tipografico Sociale, il Santo Francesco, poemetto drammatico, di cui Antos ci dà questa recensione: |
|
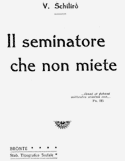
[1] Il titolo, secondo me, non fa pensare all'ottimismo, ma piuttosto a «Amo le rose che non colsi, le cose che potevano essere e non sono state» del decadente Guido Gozzano.
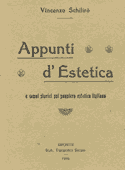
[2] «Revue néo-scolastique», pp, 488-89
Per conoscere un nostro illustre concittadino in tutti i suoi aspetti La vita e le opere di Vincenzo Schilirò scarica il libro
di Nicola Lupo
in formato  |
| Egli si avvicina al Santo con la purità e semplicità di cuore dei discepoli di Lui: lo vede, lo sente, ne respira il profumo e la santità, e può dire che cosa l'ha mosso a cantare di Santo Francesco: «il fascino della poesia che ridonda fresca e perenne dai Fioretti: il riflesso della luce chiara, mite, suggestiva, dei colli e dei ricordi umbri, della quale ho ancor pieni gli occhi» (Prefaz.). E aggiunge: «Ho lavorato ben poco di fantasia». Ma il Poeta lavorò veramente poco di fantasia? A me sembra invece che lavorò moltissimo. Poiché, se nulla egli ha tratto da un fondo arbitrariamente soggettivo, ma tutto ha desunto dalla storia, ciò non diminuisce affatto l'originalità della creazione: anzi rivela una virtù mirabile: quella che forma il poeta. La sua fantasia ha saputo far sorgere dall'ambiente storico come da un mare agitato e insieme luminoso, la serafica figura di Francesco, con cui ha parlato, vissuto e palpitato, nelle verdi plaghe dell'Umbria e in quelle arse dell'Egitto, nei momenti idilliaci e in quelli tragici o elegiaci, da solo a solo o in mezzo a quelle anime che, abbandonato il mondo, si stringevano intorno al poverello per godere la santa letizia. Dominato da questa magnifica ispirazione, lo Schilirò ha tratteggiato con molta freschezza e con molta luce le scene più poetiche e suggestive della vita francescana, riuscendo anche ad accostare, sapientemente fondendola, la nostra favella a quella del duecento: elemento formale che non tradisce nessun artificio, perché nato con le visioni stesse. [...] Ma la storia è [...] diventata realtà poetica: onde il Santo, per il miracolo dell'arte, ancora una volta vive, palpita e fa palpitare.
Nel primo atto Francesco «si stacca da un passato gaio e ancora invitante, e lotta col padre, fino ad avere il consenso e l'aiuto di Monsignor Guido». Nel secondo atto vediamo il Poverello di Dio nei pressi di Assisi, «quando già ferve l'opera sua in mezzo ai discepoli. I luoghi non ci vengono descritti ma dalla vita e dall'accento dei personaggi spira l'aura dell'Umbria verde, la Palestina francescana e, più, della Porziuncola, ormai tanto cara agli ammiratori del Santo». Il terzo atto rappresenta la missione di Francesco in Egitto. «A lui non basta la vittoria [...] sul mondo; vuole anche la vittoria sulla carne; la quale fa qui l'ultima e la più violenta apparizione». Col quarto atto siamo di nuovo nell'Umbria, tra le mura del pio monastero dove Chiara bea della sua santità le anime a lei affidate. «Le scene di quest'atto ha potuto solo immaginarle e solo può gustarle chi, con cuore puro e semplice, s'è avvicinato a cuori semplici e puri [...] tutto l'atto è un sublime idillio, di cui il Cantico del sole» è il finale magnifico: canto che fa pregustare la musica celeste e al quale quelle anime si sono da tempo preparate, compresa Maddalena, la cui umanità sembra rinata a nuova vita: la vita che Francesco le ha rivelato. Col solito trapasso lirico, nel quinto atto assistiamo alla fine di Francesco. [...] Ora che Francesco se ne va, par che tutto si renda conto di questa dipartita e si veste di malinconia e tristezza. [...]
Chi è abituato alla razionale catalogazione retorica non esiterebbe forse ad assegnarlo al Romanticismo «ma non a quello degenerativo, ma a quello di una vita consapevole e delicata, nobilitato dalla fede». Guardato cosi il Santo Francesco è l'ascesa d'una delle più belle vette della vita, e commuove ed esalta quanti si trovano sulla via dell'esilio a mirare il passaggio dell'eroe, che ascende col labaro della vittoria. |
|  |
 NOZIONI DI LETTERATURA NOZIONI DI LETTERATURA
Dice l'Antos: «Vennero in seguito, e come puramente occasionali, due opuscoletti: F.T. Marinetti e il Futurismo, scritta in occasione che lo Schilirò assistette a una conferenza del Marinetti; e Nozioni di letteratura (1929) per le scuole medie». Con ciò l'Antos, non so come, incorre in due errori: non dice che del primo si tratta della seconda edizione del 1928, mentre della prima edizione del 1919 non fa alcuna menzione. Si tratta di due brevi lavori, destinati, più o meno, tutti e due ai giovani, ma il cui schema si delinea netto e l'esposizione chiara, precisa e linda, non meno delle altre opere. [...] L'artista, nell'ispirarsi e nel comporre, deve accarezzare ed accogliere quelle visioni che tendono non a corrompere ma ad educare i costumi sociali. Ispirato poema drammatico Il Carroccio, opera di passione patriottica e di fede religiosa, ci riconduce alla calata di Federico Barbarossa in Italia nel 1162, alla distruzione di Milano e alla gloriosa battaglia di Legnano.
Il lavoro è veramente un poema, perché, nonostante del dramma abbia la forma e le proporzioni, pure la sostanza drammatica e fantastica si fonde cosi con l'ampia visione storica di quel luminoso periodo da formare un poemetto, una piccola epopea, dove l'autore profonde bellezze di scene; di verso e di lingua. Pel valore poetico Il Carroccio fa il paio col Santo Francesco; e penso che se la crisi del teatro e le difficoltà della messa in scena non ne ostacolassero la rappresentazione, l'effetto e il successo dei due lavori sarebbero sicuri. In fine Antos parla dei manoscritti dello Schilirò che potrebbero e dovrebbero essere pubblicati negli anni a seguire come: la versione in prosa della Divina Commedia (che uscirà nel 1937), un racconto veronese dei tempi scaligeri, un dramma moderno, Ombre e luci, e una commedia, Gente per bene, che non vedranno mai la luce, sebbene secondo Antos ne fossero meritevoli.[3] Non abbiamo nessuna notizia sul motivo per cui lo Schilirò non pubblicò mai i suddetti tre lavori: forse perché preso dalla collaborazione a «La Tradizione» di Pietro Mignosi e da altri lavori e riedizioni dei precedenti per i tipi della prestigiosa Casa Editrice cattolica, la SEI di Torino, che allora aveva una sede anche a Catania. E Antos conclude dicendo: Il ritiro dalla scuola e quell'appartarsi, che per lui si chiama riposo, ci fa sperare moltissimo. In quasi tutti i lavori dello Schilirò possiamo vedere l'artista già formato. Ma qui vogliamo rivolgere lo sguardo all'opera intera e veder l'ascendere di questo scrittore, non a segnar diverse tappe nel suo cammino, bensì a raggiungere la vetta luminosa d'un monte acquistato in brevissimo tempo.
Lo si è osservato critico, pensatore e poeta. E queste non sono tre attività diverse, ma tre facce dell'unica attività del suo spirito: ché egli è essenzialmente poeta, a qualunque cosa attenda. [...]
A questa virtù geniale si aggiunga la semplicità e limpidezza del dettato, che sa della tradizione manzoniana ormai uscita dalle molteplici disquisizioni sorte intorno allo spinoso problema della lingua.
Concludendo dobbiamo «considerare lo Schilirò come poeta che assomma in sé le virtù d'uomo, di letterato e d'artista». Questo, in breve, è il commiato dell'omonimo Malettese al suo confratello e amico, ma, allo stato delle mie ricerche manca la voce di un Brontese che ringrazi l'illustre concittadino per i diciotto anni spesi dallo Schilirò nella scuola, nella vita sociale, politica e culturale della nostra città. Antos ha continuato a scrivere su Vincenzo Schilirò anche dopo la pubblicazione del profilo del 1931 che avrebbe voluto ripubblicare aggiornato, senonché dovette lasciarlo incompiuto secondo la seguente Nota «Vedo bene che questo rifacimento del Profilo per ora non è opportuno. Sospendo, perciò, per continuarlo - chi sa quando ne sarà il caso», Arcip. Ant. Schilirò (7.4.1946. D.) [4] che chiude le recensioni su: Il Carroccio, Dall'anarchia all'Accademia, Schemi di concezioni storiche, Il pozzo di Sichem, Antologia mignosiana e l'Itinerario spirituale di Ada Negri, che si riportano nelle pagine seguenti.
Detti manoscritti si trovano nell'Archivio Vincenzo Schilirò in via Morosoli, 5, Catania. Un libro di Vincenzo Schilirò non pubblicato è Lucia delle Scale che partecipò al concorso Nazionale Letterario 1949 indetto da Gastoldi Editore in Milano e che ottenne la "pagella" riportata nell'immagine a destra. Bronte, dove profuse diciotto anni della sua multiforme attività didattica, letteraria e sociale, cominciò a essere stretta per Vincenzo Schilirò il quale, in occasione della fondazione de «La Tradizione» (1928), prese un anno di congedo dal Liceo Capizzi e si trasferì a Catania per intraprendere una libera attività letteraria e affidare le sue nuove opere (e la ristampa delle vecchie) alla prestigiosa casa editrice SEI di Torino. Antos nel proemio del Profilo citato dice: «[Vincenzo Schilirò] pubblica, in pochi esemplari, per gli amici. Per i lettori anonimi e sconosciuti mostra un'assoluta indifferenza». Questo suo atteggiamento, (ammesso che sia vero!) si modifica completamente quando va a Catania e scrive su «La Tradizione» di Palermo, e pubblica con la SEI di Torino, dimostrando così di aspirare a un più vasto pubblico dell'Isola e dell'Italia. Su «La Tradizione», fondata da Pietro Mignosi a Palermo, di cui Vincenzo Schilirò fu prima collaboratore assiduo, poi condirettore per la sezione Letteratura e, dopo la morte prematura del Mignosi, direttore fino al 1939, ho cercato qualche recensione su «La Civiltà Cattolica» ma ecco cosa mi è stato risposto: per il passato non si sono recensite riviste e [...] le poche richieste che ci sono pervenute hanno ricevuto una risposta negativa. Forse è una tradizione o, forse, l'esperienza dice che ci vorrebbe uno spazio troppo ampio per dare un giudizio adeguato su di una rivista. (Guido Valentinuzzi S. J.)
|
| 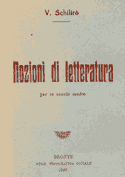
[3] Il «racconto veronese dei tempi scaligeri» è senza dubbio Lucia delle Scale che nel 1949 partecipò felicemente al concorso nazionale indetto dall'Editore Gastaldi di Milano, ma che non fu pubblicato, certamente, per la sopraggiunta morte dell'Autore.
[4] Antos, manoscritto inedito, p. 145/b
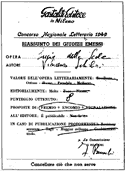
L'esito ("valore dell'opera letterariamente: ottimo; punteggio ottenuto: 8") di Lucia delle Scale presentato da Vincenzo Schilirò al Concorso Nazionale Letterario del 1949 |
|