 L’EPILOGO DELLA TRAGEDIA LEOPARDIANA L’EPILOGO DELLA TRAGEDIA LEOPARDIANA
Il 1942 fu un anno cruciale per la Sicilia a causa dell'intensificarsi della pressione bellica degli Alleati sull'isola, e lo Schilirò non pubblicò nulla, ma preparava L'epilogo della tragedia leopardiana che vide la luce, sempre presso la SEI, nel 1943. Lo Schilirò nella breve lettera alla Negri, datata Bronte 22.8.1942, commenta la situazione sottolineando «la pena che mi danno i disagi di questi poveri contadini, che hanno avuto uno scarsissimo raccolto». Eccone il testo: Cara e gentile Amica,
non ho vostre notizie da parecchio tempo. Come state? come va il vostro occhio?
Io sono ancora in campagna e ci starò probabilmente fino ai primi di ottobre.
Alla mia persistente fiacchezza nervosa si aggiunge purtroppo la pena che mi danno i disagi di questi poveri contadini, che hanno avuto uno scarsissimo raccolto.
Per caso m'è capitato per le mani il vostro articolo sul «Corriere della Sera», rievocante con delicata suggestione la specchiera di famiglia.
Scrivetemi appena potete e abbiatemi vostro aff.mo
V. Schilirò
Bronte, 22.8.1942 Da L'epilogo della tragedia leopardiana vien fuori un ritratto del Poeta «che, come dice lo Schilirò, risulta molto dissimile da quello stereotipo ranieriano». La recensione che ne fa il noto scrittore gesuita, padre Domenico Mondrone, mette in evidenza che «il saggio si scorre come un romanzetto veramente storico»; e poi passa al «pregio principale» che è la chiara disamina della «religiosità del Leopardi». E conclude: «Ci troviamo [...] dinanzi a un Leopardi cristianamente assai meno antipatico di quello che si era andato foggiando per tanti anni».[1] Ma leggiamone tutta la recensione: |
|
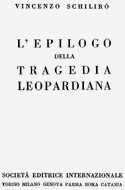
[1] «La Civiltà Cattolica», 15.4.1944.
| V. Schilirò, L'epilogo della tragedia leopardiana, SEI, Torino 1943, in 8°,212 pp., L. 20.
Dalle monografie del recanatese dott. Luigi Federici, Conversione e sepoltura di Giacomo Leopardi nel racconto di A. Ranieri (cfr. «La Civiltà Cattolica», 1941, I, 136) e Ad armi cortesi, l'A. prende occasione per esaminare altri studi di recenti leopardiani, e sulla scorta degli scritti del Poeta stesso ne forma un ritratto che, come dice lo Schilirò, risulta «molto dissimile da quello stereotipo ranieriano».
L'A. si restringe alle vicende dell'ultimo ventennio del Poeta. Sulle prime ci fa l'impressione di trovarci dinanzi a un lavoro di fantasia - e la fantasia c'entra infatti abbastanza - ma solo per quel tanto che occorre a colorire persone ed episodi forniti da testimonianze serie. Il saggio si scorre come un romanzetto, ma un romanzetto veramente storico. Pregio principale del volume è la chiara disamina della «religiosità» del Leopardi, che l’A. discute e documenta con sano criterio, con acutezza d'investigazione, venendo a conclusioni che confermano quanto già si andava ottenendo dopo studi analoghi. Messa ben in chiaro è la fine religiosa del poeta; e ottimamente narrata l'indegna commedia recitata dal Ranieri: tutta un tessuto di contraddizioni e interessate bugie. Lo studio dello Schilirò può sembrare forse animato da un'eccessiva indulgenza quando parla dello «spirituale smarrimento» del Leopardi. «Si può e si deve discutere intorno al suo concetto della Divinità; ma sarebbe arbitrario affermare che nella posizione storica del suo pensiero abbia luogo una convinta forma di ateismo». L'A. tratteggia molto acutamente l'anima del Poeta: un'anima che ha molto sofferto, e che dopo indigestioni di filosofia sensista e materialista, «cominciò a considerare e valutare la realtà soprannaturale alla stregua del suo stato fisico e psichico, e a giudicare vano il tutto sol perché gli risultavano vani i sogni e le aspirazioni». Quel «sol perché» ci dice di quanto si fosse allontanato dalla fede; ma ci lascia anche intravvedere quello che potrà la grazia, quando il timore della morte agirà come un improvviso remedium salutis. Ci troviamo così dinanzi a un Leopardi cristianamente assai meno antipatico di quello che si era andato foggiando per tanti anni. (P. Mondrone) Su L'epilogo della tragedia leopardiana Ada Negri scrive allo Schilirò il 7.2.1943: Sarebbe bene che voi pubblicaste il vostro studio sull'epilogo della tragedia leopardiana: qualcosa di esso lessi non so più in che rivista, e mi aveva molto interessata. Convengo che c'è troppa inquietudine nell'aria.
La vostra bella isola è terribilmente provata e io vivo sempre in ansia per Voi. Sarò più tranquilla quando vi saprò a Bronte. E ancora il 25 aprile 1943, aggiungeva: «Attendo da voi il saggio sulla fine del Leopardi, del quale già lessi tempo fa qualche pensosa e sottile pagina». Ma in questo periodo muore la sorella più cara di Vincenzo Schilirò il quale risponde alle condoglianze della Negri con la lettera del 21.5.1943, spedita da Bronte. Eccone il testo completo: Amica carissima,
vi ringrazio vivamente delle fraterne espressioni. Purtroppo non riesco a soffocare la mia pena, perché son convinto ch'è stato lo sgombero da Catania, non voluto da Dio, ad affrettare la fine della povera sorella.
Vero è che soffriva tanto, ma io l'amavo di più per le sue sofferenze (avevo anzi l'illusione che la debole fiammella della sua vita, alimentata fiato per fiato con mille cure, mi appartenesse di diritto) e lei stessa portava quasi ilare la sua pesantissima croce pur di seguitare ad essermi compagna nel mio non facile cammino. Unico sollievo mi è il pensare che il suo martirio si sarebbe potuto rendere più crudo; e ciò mi aiuta a sopportare il nuovo senso di solitudine in cui son caduto e che gli altri sinceri affetti - il vostro fra i primi - mitigano notevolmente.
Grazie di nuovo e abbiatemi, nella più santa e viva fraternità, vostro aff.mo
V. Schilirò
Bronte, 21.5.1943[2] E il 18 giugno la Negri scriveva ancora: Mi è giunto il vostro volumetto sugli ultimi anni del Leopardi e sulla sua morte cristiana. Già avevo letto di esso qualche saggio con l'interesse che ogni opera vostra m'ispirava. È un'opera breve, ma intensa e forte, molto ben documentata, che mette spietatamente in luce l'antipatica figura del Ranieri, e una volta di più ci fa soffrire per le sofferenze del Poeta. Con quale scotto si paga il genio, Amico mio!
Il libro è stampato assai bene, Vi ringrazio di avermene fatto dono. E infine il 1° luglio del 1943, da Bollate (MI) aggiungeva: Penso che il vostro bello e pensoso volume sugli ultimi anni del Leopardi avrebbe dovuto uscire in migliore tempo. Ma come sarà il tempo che verrà? Oggi il bollettino [di guerra] annuncia ancora disastri a Palermo.
Povera cara isola, che martirio! Ho il cuore pesante come pietra. Fate bene a rimanere definitivamente in campagna. [alla masseria Macchiafava in contrada Placa a Sud-Ovest di Bronte]
 Gli scritti di Sociologia Gli scritti di Sociologia
L'attività sociale espletata dallo Schilirò nel periodo brontese ha avuto poi una sistemazione teorica dopo la liberazione della Sicilia con la pubblicazione di tre opere uscite tutte e tre nel 1945 e cioè: SINTESI DELL'EVOLUZIONE STORICA DEL PROBLEMA SOCIALE, che è un esauriente excursus del problema sociale dal corporativismo medievale, al liberalismo, al marxismo, al bolscevismo russo, ai regimi totalitari dopo Versaglia fino alle soglie del nuovo dopoguerra; seguito, in appendice, dalla dottrina sociale della Chiesa esposta nell'Enciclica di Leone XIII Rerum novarum.
Questo lavoro trasferisce nel lettore le idee chiare che ha l'autore del problema trattato e, in parte, da lui attuato nella pratica della vita sociale del «natio borgo», per servire da esempio alle nuove generazioni. |
| [2] Queste lettere provengono dal Fondo Scalfi (il cognome della Negri da sposata), conservato dalla Fondazione Ada Negri, presso l'associazione culturale Poesia, la vita! di Lodi, presieduta dalla dott. Laura Prèmoli De Mattè.
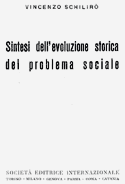
| AUTONOMIA è il secondo dei tre testi teorici di sociologia dello Schilirò, nato in primo luogo per contrastare il movimento separatista, sorto in Sicilia dopo la liberazione; ma anche per dimostrare storicamente che la Sicilia aveva diritto a una certa autonomia perché il centralismo si presentava, come in seguito è avvenuto, come un pachiderma dai movimenti lenti e impacciati e dannosi per la vita degli enti sociali. Le regioni per esempio, previste nel 1948, furono realizzate (e come, poi!) solo nel 1970.
Lo Schilirò termina proponendo l'armonizzazione dei poteri dello Stato centrale con le autonomie locali sui tre piani: sindacale, amministrativo e politico.
Due dei tre scritti di sociologia di Vincenzo Schilirò sono brevemente ma sinteticamente recensiti da padre Brucculeri S. J. su «La Civiltà Cattolica» dell'ottobre del 1945, il quale conclude dicendo che «queste pagine [...] saranno accolte con interesse da chi voglia orientarsi sul terreno sociale». Vediamone la breve ma chiara orientativa critica: V. Schilirò, I: Sintesi dell'evoluzione storica del problema sociale, SEI, Catania 1945, in 16°, 181 pp., L. 130; II: Autonomia, Ibid., in 16°, pp. 68, L. 60. Il prof. Schilirò così ben noto per le sue pubblicazioni letterarie, in questo lavoro ci dà un quadro dell'evoluzione del pensiero intorno al grande problema della nostra epoca: il problema sociale. Egli esamina l'una dopo l'altra le soluzioni che si son date della questione sociale: la corporativa medievale, la liberale. la socialista, la cattolica, la bolscevista, per terminare con un riassunto della dottrina sociale della Chiesa. Queste pagine snelle, serene, vibranti di umanesimo cristiano saranno accolte con interesse da chi voglia orientarsi sul terreno sociale. Troppo smilze ci appaiono le pagine dedicate al bolscevismo e assai benevolo il giudizio che se ne dà.
Nel secondo volumetto l'A. combatte vittoriosamente il centralismo despotico e snervante dello Stato moderno.[3] |
|
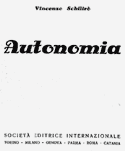
[3] «La Civiltà Cattolica», 20.10.1945.
| LIBERTA' E DEMOCRAZIA è, invece, il programma della Democrazia cristiana che, visto nella realizzazione che ne è venuta fuori in questo cinquantennio, sembra proprio il libro dei sogni di un animo puro che aveva sconfinata fiducia nei suoi simili.
Mi ha sorpreso la seguente asserzione: «Libertà di educazione implica necessariamente un'altra libertà: quella d'insegnamento. Presso le nazioni veramente civili dovrebbe cessare lo sconcio del monopolio scolastico statale. Fermo il principio che la formazione giovanile spetta decisamente ai capi di famiglia, risulta logica e necessaria l'esistenza di liberi istituti d'educazione e d'insegnamento».[4]
Perché, d'accordo sul primo periodo, noto una insolita durezza di linguaggio in Padre Schilirò che parla di sconcio del monopolio scolastico statale, nel secondo periodo, cosa che, se riferita, come sembrerebbe, all'Italia di allora, non risponde affatto alla realtà: infatti non c'era monopolio e prosperavano «liberi istituti d'educazione e di insegnamento».
È vero, però, che proprio nel 1944-45 cominciarono richieste di statalizzazione di scuole private ma solo per motivi economici, in quanto dette scuole costavano troppo ai loro utenti.
Vedi, proprio, il caso di Bronte, che solo dopo quella richiesta ottenne scuole statali per tutti. Ma ciò non ha nulla in contrasto con la libertà di insegnamento e di educazione, se non implica l'aspetto finanziario. Questo concetto entrò poi nella Costituzione del 1948.
A questo punto dobbiamo inserire un breve documento di Antos che recita: Nota. – Vedo bene che questo rifacimento del “Profilo“ per ora non è opportuno. Si sospende, perciò, per continuarlo – chi sa? – quando ne sarà il caso. 7. 4. ’46 D. Arcip. Ant. Schilirò. Io ho tentato di avere notizie e prove sull’ aggettivo “opportuno“, usato da Antos a proposito della continuazione dell’aggiornamento del suo “Profilo“ di Vincenzo Schilirò, pubblicato nel 1931, ma non ho trovato nulla. Perciò ho provato a fare delle ipotesi e alla fine mi sono soffermato sulla seguente: Vincenzo Schilirò nel 1946 pubblica “ Jadwiga“ e forse qualcosa di questo romanzo d’amore, stile ‘800, l’ultima sua opera, non sarà piaciuto a qualcuno (della Curia di Catania?), il quale dissuade Antos, arciprete di Maletto, dal proseguire il “Profilo”. |
| 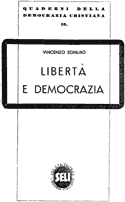
[4] Vedi “Il Liceo Capizzi” e nota la contraddizione!
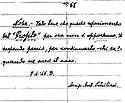
La nota di Antos
| Antos recepisce il “consiglio” e sospende il suo lavoro firmando e premettendo al suo nome la sua qualifica. Plausibile e realistica questa ipotesi? …
 JADWIGA JADWIGA
Il secondo romanzo di Vincenzo Schilirò Jadwiga, pubblicato nel 1946, «non fa dell'antifascismo postumo» perché fu scritto in pieno periodo fascista, ma «non fu approvato per la stampa dalla censura preventiva del MinCulPop».[5] Ne parla diffusamente padre Mondrone di «La Civiltà Cattolica» nel giugno 1947, il quale asserisce che «più che un romanzo, il libro è la tragedia di questi due personaggi principali: il Vitali (maestro di violino), perseguitato dalla polizia fascista, e la sua alunna e discepola spirituale Jadwiga Kierz. A lei il Vitali, fra l'altro, scrive: «mi piace immaginarti come il simbolo della libertà interiore». Ma leggiamo tutta la recensione che ne ha scritto il più assiduo critico delle opere di Vincenzo Schilirò: V. Schilirò, Jadwiga [Romanzo], Gastoldi, Milano 1946, in 8°, 168 pp., L. 150.
In una premessa l'A. ci fa sapere che il suo romanzo non fa dell'antifascismo postumo, essendo stato scritto quando il regime fascista era in auge, ma non fu approvato per la stampa dalla censura preventiva dal Ministero della Cultura Popolare. Incerti se dire che protagonista sia il maestro di violino Giovanni Vitali oppure la sua alunna e discepola spirituale Jadwiga Kierz.
Più che romanzo, il libro è la tragedia di questi due personaggi principali: il Vitali è un perseguitato dalla polizia fascista e finisce, dopo di essere arrestato, non si sa dove; Jadwiga dal suo soggiorno di Berna, dove contemporaneamente le giungono la notizia dell'arresto del maestro e del bando dal quale è colpito suo padre come ebreo, ma senza esserlo, corre in Sicilia in traccia del maestro, e non avendolo trovato, stanca, amareggiata, disillusa, va a bussare alla porta d'un convento per trovar pace «in quell'asilo di anime rifuggenti gl'inganni e le risse della vita mondana». In una delle ultime lettere, il Vitali le aveva scritto: «Prevedo tempi tristissimi ma son tranquillo, perché fido in Colui che ci è Padre e non può abbandonarci.
Tu, che non hai patria, hai un legame sentimentale di meno, e mi piace immaginarti come il simbolo della libertà interiore, che preferisce di andare raminga pur di scansare la tirannia degli uomini».
Il romanzo ha una trama molto schematica. e ben condotta da quelle che sono le sue creature più vive, il Vitali e Jadwiga: non mancano pagine di efficace psicologia e la lingua è buona. (P. Mondrone)[6] Ma c'è una più significativa recensione de «La Civiltà Cattolica» a firma di padre Domenico Mondrone S. J. che presenta l’edizione congiunta de La credenza carducciana e Il romanticismo e gli amici pedanti del 19l2-17, pubblicata dalla SEI di Catania nel 1946. In tale riedizione lo Schilirò tenne conto dei progressi fatti dagli studi carducciani dal 1912 al 1945 approfondendo «i valori spirituali dai quali anche il Carducci attinse ispirazione e vita». Leggiamone l'interessante e lungo testo: V. Schilirò, Carducci «pedante» e credente, SEI, Catania 1946, in 8°, 344 pp., L. 300.
Ricompaiono, in questo volume, due scritti dall'A. pubblicati oltre una trentina di anni or sono: Il romanticismo e gli amici pedanti e La credenza carducciana e suo valore, nel primo dei quali illustrava l'indirizzo estetico del Carducci, nell'altro l'atteggiamento religioso del poeta: «due aspetti male conosciuti e, in campo critico, scarsamente apprezzati». Tuttavia, poiché dal lontano 1912, al quale risalgono quegli scritti, ad oggi gli studi carducciani certamente più di un passo hanno compiuto, l'A non ha voluto prescinderne, e da parte sua non ha mancato di venire a un maggior approfondimento di quei valori spirituali, dai quali anche il Carducci attinse ispirazione e vita. Tutta la prima parte del volume rifà la storia dell'affacciarsi del Carducci alla ribalta letteraria, nel rissoso gruppetto degli «amici pedanti, scesi in lizza contro il romanticismo, fino al tempo che si rivela poeta; periodo di lotta, ma di preziosa maturazione, durante la quale il Carducci «è venuto emancipandosi dal precettismo di scuola e dando più attento ascolto ai sensi umani, di cui si alimenta la poesia genuina, nemica di qualifiche e di appellativi.» (p. 132). Tutto questo periodo di trapasso è densamente documentato e seguito punto per punto dallo Schilirò con serio ed acuto accorgimento. Anche la seconda parte - che è la più interessante del volume - è tutta un documentario attento e intelligente per ricostruire la fisionomia del Carducci credente. Poiché dalla bibliografia, ormai vastissima del poeta «affiora, dice lo Schilirò, appunto questo duplice svisamento della realtà storica: un Carducci vessillifero dell'ateismo e ferocemente anticristiano, e un Carducci capricciosa farfalla e banderuola al vento» (p. 310). Attento sempre a non lasciarsi prendere alla sprovvista dalla documentazione di parte interessata, e ancora più attento a non forzare la verità storica, lo Schilirò prende a seguire il Carducci dalla prima giovinezza fino al tramonto studiandolo passo per passo e raccogliendo tutto quello che può avere un'importanza rivelatrice nei diversi atteggiamenti religiosi del poeta e nel loro obbiettivo ed intrinseco valore. Le conclusioni alle quali giunge son queste: che il Carducci ebbe dalla natura uno spiccato sentimento religioso; nella Divinità credette quasi sempre, essendo molto discutibili anche i periodi di satanismo ed ateismo; anticlericale fu, ma in funzione politica, convinto che il Vaticano, i preti, e la religione positiva erano di ostacolo all'unità d'Italia: incappò nella massoneria, credendola altamente umanitaria e sostenitrice della più ampia libertà umana; tale anticlericalismo lo allontanò dalle pratiche religiose, dalla fede nella divinità di Cristo, ma non ne offese i riti: nell'età matura venne superando preconcetti anticlericali, e riavvicinandosi alla religione della sua fanciullezza, le deposizioni che attestano di aver ricevuto i sacramenti sono attendibili, ma non decidono del tutto la questione; la massoneria gonfiò e sfruttò a fondo l'anticlericalismo del poeta, senza tener conto, anzi volutamente mettendo a tacere quanto attestasse l'ulteriore evoluzione spirituale del Carducci. Il libro dello Schilirò è quello che ha meglio di ogni altro esaminato il problema, e notevole è il contributo che apporta a un più equo e veritiero giudizio in riguardo alla religiosità del poeta, e al valore di tale credenza. (P. Mondrone)[7]
Con il 1948 Vincenzo Schilirò chiude la sua «libera attività letteraria», ripubblicando, sempre presso la SEI, Il pozzo di Sichem e L'itinerario spirituale di Ada Negri, arricchito di lettere inedite della poetessa.
Nella raccolta di liriche «il dolore detta al poeta un tono malinconico e sofferto e gli fa sentire un intenso desiderio di purificazione». In questa raccolta lo Schilirò «allarga l'approccio con la poesia moderna». Ne L'itinerario..., che ebbe «un largo riconoscimento dei suoi pregi», l'Autore aggiunge ora una quarantina di brani di lettere «che fanno luce - dice egli - su particolari stati d'animo di lei e servono a convalidare quanto son venuto asserendo in questo libro. [...] Questo epistolario, per il lettore serio, non è una inutile curiosità». Ecco la breve citazione della seconda edizione de L'itinerario...: V. Schilirò, L'itinerario spirituale di Ada Negri, con lettere inedite della poetessa, SEI, Catania 1948, in 8°, 280 pp., L. 300. Questo saggio fu già da noi recensito con largo riconoscimento dei suoi pregi (cfr. «La Civiltà Cattolica, 1939, I, 371). L'A. vi aggiunge ora una quarantina di brani di lettere «che fanno luce, dice egli, su particolari stati d'animo di lei e servono a convalidare quanto son venuto asserendo in questo libro».
Ci sembra che non solo servano a «convalidare», ma anche a completare certe linee meno note della fisionomia di Ada Negri. Quanti conservano simpatia per la poetessa leggeranno con piacere questi nuovi documenti della sua anima. Perché - pensi lo Schilirò quello che vuole e lo dica pure con parole grosse - l'epistolario d'un personaggio comunque passato alla storia desta sempre dell'interesse, e questo, per il lettore serio, non è una inutile curiosità. (P. Mondrone) Negli ultimi anni della Sua vita Vincenzo Schilirò aveva ripreso l'argomento trattato su «La Tradizione» del gennaio-febbraio 1933 su Catania e la sua Santa per scrivere una biografia di sant'Agata, protettrice della città di Catania. Ma non ho trovato altra traccia nell'archivio della casa di via Morosoli, 5 in Catania, dove speravo trovare qualche manoscritto sull'argomento. (pp. 35, 148/a) Dalla lettura di alcuni testi dello Schilirò e delle recensioni e giudizi critici di eminenti letterati si può ricavare un dato fondamentale: lo Schilirò ha avuto due principi ispiratori di tutta la sua vita e la sua opera: la fede in Dio e la fiducia nella socialità dell'uomo; e il suo concetto dell'arte come «fatto interno, sintetico, individuale e originale». Perciò in tutti i suoi lavori cerca la credenza e la fede dei suoi personaggi: dal Carducci al D'Annunzio, dal Pirandello alla Negri; fede e credenza che, a prescindere dalla "chiesa" di appartenenza, mettono in evidenza la onestà intellettuale dei soggetti, la genuinità e la sincerità dei loro sentimenti, al di fuori di ogni ortodossia che spesso non è che conformismo e opportunismo. E tutto ciò coincide con l'essenza del Modernismo dello Schilirò il quale crede e lotta per una coscienziosa convinzione nell'onestà intellettuale e opera per il rinnovamento morale e sociale dell'uomo che va curato anche nei suoi bisogni materiali e sostenuto nei suoi rapporti sociali: vedi il suo lungo periodo di insegnante e drammaturgo, di operatore sociale e finanziario, di giornalista pubblicista e operatore culturale e uomo politico. Lo Schilirò tende, con il suo multiforme lavoro, a Dio cosi come vede Ada Negri per percorrere il suo itinerario spirituale che culmina nei versi di Vespertina. Il letterato brontese dimostra che, come da Dio, dalla fede e dal Sacerdozio, ai quali è sempre rimasto fedele, egli è arrivato all'uomo e al sociale, così la Negri dal socialismo e dalla lotta per l'uomo è arrivata, dopo un lungo e tormentato itinerario, a Dio e alla fede cristiana.
|
| 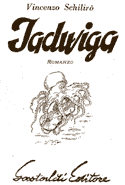
La censura del MinCulPop
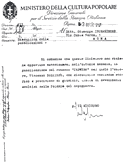
Ministero della Cultura Popolare
2 Marzo 1942 XX
Si comunica che questo Ministero non ritiene opportuno autorizzare, nell'attuale momento, la pubblicazione del romanzo "Jadwiga" nel quale l'autore Vincenzo Schilirò con discutibile esattezza storica e precisione di giudizio, tratta di avvenimenti svoltisi nella Polonia del dopoguerra.
[5] Franco Cimbali, bibliotecario del Collegio Capizzi, scrive questa scheda bibliografica: «Jadwiga fu scritto in pieno regime e, per tale motivo, la trama del romanzo venne spostata dall’autore in terra polacca. Anche qui c'e un dittatore, imbevuto d'assolutismo, che detiene il potere e governa lo Stato con dispotismo. Per precauzione il manoscritto, dall'Editore Mario Gastaldi, fu inviato ai Ministero Popolare e il 2 Marzo 1942 il MinCulPop rispondeva che, dopo lunga ponderazione, non riteneva autorizzarne la pubblicazione (non condividendo l'Autore, modi e metodi dittatoriali che esternava tramite i protagonisti del romanzo.)
[6] «La Civiltà Cattolica», 21.6.1947.
[7] «La Civiltà Cattolica», 15.6.1946.
|
|