Abbiamo citato spesso questa rivista[1] la cui fondazione nel 1928 da parte di Pietro Mignosi determinò, secondo me, l'abbandono dell'insegnamento a Bronte e il trasferimento dello Schilirò a Catania per continuare, intensificare e diffondere meglio la sua libera produzione letteraria. Ma ora, credo, sia opportuno parlarne un pò sistematicamente per vederne meglio l’impegno in essa profuso dal Nostro. Nei primi anni vediamo Vincenzo Schilirò come componente della redazione siciliana (le altre due redazioni erano quella napoletana e quella romana), mentre dal fascicolo del gennaio-febbraio 1933 vediamo il suo articolo su Catania e la sua Santa (in cui compare anche una recensione di Pietro Bargellini su San Bernardino da Siena di F. Bruno). Nel 1935 notiamo che la rivista adotta la doppia direzione: al settore Storia, Filosofia e Cultura resta il fondatore Pietro Mignosi, mentre al settore Letteratura viene delegato Vincenzo Schilirò il quale introduce il suo nuovo incarico con un articolo intitolato Perché?.. che riproponiamo. Perché? ...
M'è stato domandato più d'una volta: perché «Tradizione» non s'ingegna a diventare più varia e allettevole, più accessibile e redditizia?... Ho risposto: «Perché nacque discretamente fornita d'idee ma del tutto povera di attrattive: e, ad imbellirla non servono trucchi e matite. Se di essa qualcosa vale, vale il suo viso schietto. Bisogna dunque compatirla. Chi nel bere alla luce e al caldo del sole un bicchiere d'acqua limpida, non sarebbe disposto a compatire gli umili e volenterosi terrazzieri che nelle viscere della terra sudarono tanto per rintracciare, nel buio fangoso, la fresca polla? «La Tradizione» nacque precisamente per scavare nei meandri oscuri della verità, dove il tormento dell'anima è peggio del buio. Poi, a convogliare le sorgive, provvedono i tecnici in blusa pulita, e abbastanza presentabili. Lavoro più appariscente, ma di secondo tempo.
Qualche altro m'ha detto che la rivista pare come tagliata dalla vita pratica e realizzatrice. «La vita sociale e politica vi ha scarsa risonanza; i problemi corporativistici, per esempio, non vi sono affrontati...» I miopi son fatti così. Han bisogno di vedere e di toccare con la punta del naso. Se invece potessero guardare da più lontano, si accorgerebbero che, pei moderni transatlantici della vita, noi ci preoccupiamo della rotta, non dell'organizzazione tecnica e finanziaria; e saprebbero già che i cattolici, fedeli alle encicliche leoniane e alla scuola sociale cristiana, non possono essere che per la collaborazione di classe e pel corporativismo. Del resto (ripetiamo) questa rassegna non nacque per un lavoro di superficie, ma per smuovere il terreno inesplorato, per scavare in profondità, per rinvenire rigagnoli nuovi e dissetanti; fatica modesta e di scarsa appariscenza, ma indubbiamente atta a migliorare il clima delle anime. Abbiamo la certezza che oggi, nel trambusto o nel marasma che fa soffrire la maggior parte dei popoli civili, e nel magnifico sforzo dell'Italia che oppone una sana concezione sociale ai ripieghi fallimentari del liberalismo e al bacato esperimento sovietico, più d'ogni equilibrismo o servilismo ipocrita e accattatore giovi il silenzioso lavoro dei cattolici, che della disciplina, dell'ordine e della gerarchia possiedono il convincimento e il culto: giacché sono essi che, agli ordinamenti sempre evolventisi della società, si cooperano a dare un'anima e un cemento insostituibile: la fede religiosa e la parola della fraternità cristiana. Solo dove è Dio si rischiara la vita dei popoli; senza solidarietà cristianamente intesa, non si concepisce un pacifico e laborioso aggregato sociale.
Difatti la lotta che si sta combattendo con ampiezza di mezzi e di strategia nel vecchio e nel nuovo mondo (dalla Spagna alla Russia, dal Messico alla Germania) è soprattutto guerra interiore fra tendenze irriducibili; amore ed egoismo, fede e miscredenza, sacrificio virtuoso e brutalità d'istinti. Negare o affermare Dio, equilibratore della vita: è questo l'ultimo significato delle umane rappresaglie. Riconoscere all'uomo il diritto e la possibilità di ascendere, ovvero inchiodarlo alla terra, nel più amaro sbigottimento o nella più forsennata ambizione, perché si sbrandelli inutilmente dentro lo spinaio dell'odio, delle contese e del disinganno. Segno di perenne contraddizione, Dio è la sola Realtà che concentra e assolve tutte le realtà, e che nessuna forza, nessuna legge, e nessuna umana conquista potrà mai soppiantare. Ebbene: questa rassegna lavora e soffre e gioisce intorno a quel segno di contraddizione, lasciandosene del tutto dominare. È perciò che, mentre tutte le pubblicazioni a principio del nuovo anno si agghindano, s'imbellettano e si offrono con maggiore o minore vantaggio, essa è lieta di rimanere al suo posto di fatica: già, nel buio, a cercare l'acqua perennemente viva. Nel 1937, per la malattia del Mignosi e il trasferimento della Direzione a Catania, lo Schilirò ne assume la direzione unica che manterrà fino alla cessazione della pubblicazione nel 1939 (nelle pagine di questo numero della Tradizione c'è anche un Avvertimento in cui vengono comunicati i nuovi incarichi e i nuovi indirizzi anche per quanto riguarda Tradizione Editrice). Nello stesso anno 1937 lo Schilirò pubblica un altro articolo in cui fa il punto nel momento in cui avviene il cambio della guardia alla direzione della rivista con il trasferimento a Catania della stessa. Eccone il testo. Anno 1937 «Tradizione»
Un ciclo essa ha chiuso sul versante tirrenico e un altro ne apre su quello jonico. Questa povera bandiera di carta limosinata non si ammaina ancora: che i suoi fedeli sentono e credono di poter portare qualche altro contributo al comune patrimonio della cultura.
La rassegna siciliana non ha salvato il mondo e non ha compiuto miracoli, ma saremmo ipocritamente modesti se non rivelassimo che inutile non è stata. Nata in un tempo che il pensiero italiano era permeato di idealismo e gli scrittori cattolici, sospettati di modernismo o sedotti dalle audacie rosminiane, patirono l'isolamento, essa riuscì ad innestarsi sul tronco ancora vivo del movimento democratico-cristiano dell'isola, dove il fervore delle opere sociali (stampa, casse, cooperative, associazioni, circoli di studio) aveva acuito maggiormente il bisogno di una nuova formazione spirituale e dove l'attualismo gentiliano aveva combattuto con fortuna le sue prime battaglie; ma, per fare opera di penetrazione, essa superando (senza mai tradirlo) lo stretto ambito del confessionalismo, prese decisamente contatto con le più oneste correnti intellettuali della penisola, suscitando importanti dibattiti e discutendo a porte aperte. Adesso che il fascismo ha orientato la vita della Nazione verso la civiltà cristiana e cattolica, e si contano sulle dita i pensatori e gli artisti che fingono di ignorare i valori religiosi dello spirito, torna assai comodo ai borbottoni disutili affermare che la rivista nei suoi primi anni non fu né carne né pesce, asilo com'era di tutte le firme e tribuna delle più disparate asserzioni. Angustia farisaica, insensibile al cristiano proselitismo. Ma i fatti sono quelli che sono. Questa male incoraggiata insegna, tipograficamente sciatta e di irregolare periodicità, ha resistito onorevolmente a parecchi scontri e a molte lusinghe, pigliandosi con rassegnazione le botte degli avversari e le intemerate degli amici: discretamente soddisfatta del suo bilancio. Nell'incalzare fino agli estremi confini i sottilizzamenti idealistici si è creduto talora che «Tradizione» platoneggiasse un po' troppo e, nel seguire i farneticamenti del pensiero moderno, si scostasse dalla via diritta; ma sanno i critici onesti che non c'è strategia la quale presuma di disciplinare l'inseguimento del nemico come in piazza d'armi; e sanno pure che lo scolasticismo è il mallo transitorio della filosofia perenne. Fatto è che la rivista non ha mai perduta la sua polarizzazione tomistica, fra i due eccessi del fenomenismo sperimentale e del sonnambulismo dialettico. Altro suo merito innegabile è l'avere contestato agli idealisti il monopolio del pensiero estetico, e l'avere sufficientemente chiarito che meglio della filosofia hegeliana o baumgartiana, il sano concetto dell'arte armonizza con le tradizioni del pensiero italiano e cattolico. E non è necessario ricordare che l motivi estetici dell'arte d'annunziana (1917) e gli Appunti di estetica (Arte = Vita) di V. Schilirò, Saggio sull'arte creatrice (1919) di G.A. Cesareo, Alle fonti della bellezza (1928) di P. Maltese e Arte e Rivelazione di P. Mignosi sono libri siciliani, le cui disamine la rivista ha con larga risonanza animato e messo in gara. Altra battaglia combattuta e stravinta è stata quella impegnata contro il vaniloquio ed il calligrafismo letterario onde dare o far riconoscere uno scopo e una dignità alla poesia e all'arte in genere: tanto che non fa più specie (ora che il terreno è sgombro di tutti i paladini dello stilismo infecondo e liberaleggiante) vedere periodici e almanacchi che fanno chiassose professioni di antiletteratura.
E potremmo anche rammentare la posizione assunta dalla rivista nel dibattito di problemi educativi e le sue non difficili previsioni sul graduale delimitarsi e sulla portata storica dei contrasti ideologici e sociali; ma andremmo troppo per le lunghe, e, al postutto, non dimostreremmo altro che essa è venuta attingendo direttamente e con larghezza dal tesoro inesausto della verità cristiana: la quale non è somma di astrazioni o vernice di confessionalismo ma rettitudine di vita, coscienza del dovere fino al sacrificio, carità in atto e certezza del regno di Dio.
Dicevamo che non è ancora esaurito il programma di «Tradizione». Pensiamo che, in realtà, le umane vicende siano delle filosofie in cammino, anche se truccate fino alla irriconoscibilità. E la nostra vocazione è quella di seguire la logica segreta ed infrangibile degli avvenimenti, che né sofismi di consessi diplomatici né illusioni di masse riescono a modificare o a corrompere. Non presumiamo, no, di pesare sulla imponente bilancia delle forze che si contendono in questi anni fortunosi la signoria del mondo; né con semplicismo fatuo ci volgiamo a sistemi, a formule, a ricettari. Ma, convinti che gli eccessi e l'instabilità degli attuali ordinamenti derivano dal dilungarsi degli uomini dalla legge etica e dalla concezione religiosa della vita (tanto di fatto oscillano a destra il contratto sociale di Rousseau e l'ateismo di Voltaire quanto si sbandano a sinistra l'economia politica di Marx e il misticismo materialistico di Lenin) non ci stancheremo d'insistere sulla via mediana dell'insegnamento cattolico, che non polverizza gli aggregati sociali isolando ed emancipando l'individuo, e non immola la realtà individua alla vanità degli aggregati astratti. Fuori dell'ambito romano e cristiano, il duello impegnato dalle varie correnti politiche mondiali si determina appunto nell'amorale liberismo sassone e commercialista che ha dominato questa agonizzante età agnostica, e nell'utopia anarcoide e rossa, che tenta di cancellare l'individualismo umano inquadrando i popoli come greggi al pascolo e riducendo la vita pubblica ad una clausura fra schiavista e conventuale.
Nel grande organismo umano il fenomeno spagnolo non è che un'esplosione sporadica del pus dottrinario che vi circola da secoli, combattuto coi soliti cerotti e coi soliti pannicelli caldi; e avremo modo di venir constatando che i popoli non possono trovare riposo lontano dal Vangelo, secondo cui il dramma della vita è dramma di individui singolarmente responsabili, ma indissolubilmente legati fra loro, da vincoli di fratellanza e di amore.
E non perderemo di vista né l'altalena del pensiero che, vergognoso del suo delirare neo-kantiano, tende a un neo-positivismo di dubbio significato né certa sospetta tenerezza per la scienza, alla quale si tenta spesso di affidare l'indecoroso ruolo di mezzana. Ci ingegneremo di rendere la rivista più interessante ed accessibile: che è come dire più adatta a questo clima etneo. Cosa naturalissima per «Tradizione», la quale da Palermo (città di santa Rosalia, eroina dello speco) passa a Catania, stadio aperto della martire Agata.
Ma, più o meno speculazione, più o meno poesia, che cosa importa? Nonostante gli abiti mutevoli delle stagioni, la rivista conserverà immutati il suo volto e la sua anima. In una immaginaria, credo, lettera ad un amico, intitolata A un'anima in travaglio, lo Schilirò parla del «tormento» che si prova di fronte a «qualche problema fondamentale dello spirito e della vita», tormento che «si dissimula [...] a questo ambiente torbido, mercantesco, rissoso, e talora eroico, in cui viviamo». Dice delle «giovanili illusioni di una vita protesa verso un eden di materiale benessere e di fraterna uguaglianza» illusioni trasformate in «un groviglio di geroglifici, passioni oscure che agitano uomo contro uomo, interessi larvati o manifesti che armano nazioni contro nazioni, ideologie complicate che [...] orientano e rimenano i popoli verso le selve preistoriche». E ne prova delusione, ponendosi gli eterni interrogativi: «Che siamo? a che la vita? dove e quale la verità?» E dalle considerazioni pessimistiche passa al «problema indeclinabile della personalità». Hai purtroppo toccato con mano - dice all'amico (se stesso?) - quale significato abbiano, nel libro della storia, le parole diritto, legge, uguaglianza, filantropia ecc. per concludere con parole di condanna della tirannia e di sfiducia nella democrazia. Hai la piena convinzione - continua - che la struttura sociale a carattere essenzialmente materialistico e contenzioso non offre speranze di verace e duraturo incivilimento. Per gli onesti non resta, quindi, che il «dilemma: ribellarsi o rassegnarsi. [...] La fede in una vita che valga la pena di essere vissuta, la fede in una Civiltà (con la C maiuscola) che degli uomini disseminati nel mondo avrebbero fatto un'unica famiglia, intesa all'equità e all'amore, e vittoriosa dei malanni del corpo e dello spirito» ha vacillato provocando delusione e amarezza e la vita ti appare «una goffa commedia senza perché». Benedice la crisi dell'amico perché «vedevo che con essa si iniziava la salutare reazione del tuo spirito», che scorge non il bivio della ribellione o della rassegnazione, ma una terza via «più erta e costosa, ma che mena assai in alto» dove «il problema della personalità si pone, a quella quota, sotto migliore luce e nella sua interezza». E così si «risolve il problema di Dio» e si ha «un concetto passabile della Divinità», senza Dio non si spiega nulla ma in Lui «questa nostra esistenza trova la sua legittima spiegazione».
«Ma chi presumerebbe di conoscere Dio?» chiede (e si chiede) Vincenzo Schilirò. Dio non si può conoscere, ma solo «sentire [...] è con l'umile aderenza alla volontà di Lui che essa può meritare la grazia di non venir delusa nelle sue naturali aspirazioni».
Entrati così «nel labirinto metafisico» complicato dal «problema morale» si ha bisogno di «un filo d'Arianna per rinvenire la certezza, base della religione positiva» che «è il cattolicesimo». «Quel filo d'Arianna, da noi cattolici, chiamato Grazia, lo dà Iddio». Ma tra l'uomo e Dio c'è una sconfinata distanza che «bisogna ammettere vinta, affinché si possa parlare di veritiera religione positiva». Ma «poiché l'uomo (è) limitato nei suoi mezzi conoscitivi [...] è ovvio che, a rivelarsi alla nostra anima, debba essere Dio. Ma come? come?» sembra chiedere l'amico «in travaglio» con un grido straziante. Con le «rivelazioni divine del cattolicesimo» incentrate «nel fatto stupendo della Redenzione», Cristo «ha varcato la infinita distanza fra il Creatore e le creature».
La vita non avrebbe senso né ombra di giustizia se staccata dalla promessa evangelica. Ignorare Cristo, arcano anello di congiunzione fra la terra e il cielo, è tagliarsi la strada d'accesso alla Verità. Poi ritorna ancora sulla Grazia «segno foriero della redenzione» e «dono gratuito e fecondo, reattivo che dissolve le umane miserie, coefficiente di spirituale integrazione, lume che capovolge l'estimo della terrenità».
Alla «luce della Grazia le beatitudini predicate da Gesù sulla montagna, diventano, non solo intelligibili ma addirittura basilari nel regno della Verità». |
[1] La denominazione "La Tradizione" è tutto un programma: fedeltà alla "tradizione" cristiana nel contesto della situazione socio-culturale del tempo (anni 1928-1939), contro l'idealismo di Gentile e di Croce, con l'occhio teso al problema sociale, in sintonia con l'indirizzo dell'Enciclica di Leone XIII Rerum Novarum, come viene ribadito nei due articoli di Vincenzo Schilirò "Perché? ..." e "Anno 1937 «Tradizione»", che riportiamo di seguito.
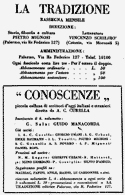
|
Tu, per la tua finezza interiore, hai già subito il gran fascino di Cristo. Di ciò mi dà la conferma quel nano culto che hai per l'amore: base, fine, essenza della religione cristiana. Ma non nascondi di non saper dar credito alla Chiesa, perché la vita dei suoi membri ti appare ben diversa da quella che Cristo vuole, in alto, in basso, fra chierici e laici, nei singoli e nella collettività.[2]
Alla tua domanda: «Ma, dopo saziato il ventre e placate le esigenze della mondanità, si sarà anche tacitata l’aspirazione più profonda dell'anima umana?», è questo il cardine del tuo «travaglio». Accettare la parola di Cristo significa inchinarsi in umiltà di spirito alla Verità [...] e chiedere con risoluta prontezza: «Che vuoi, Signore, ch'io faccia? In uno dei numeri de «La Tradizione» che ho potuto visionare ho trovato un pregevole saggio sul dolce stil novo, in cui lo Schilirò, partendo dal canto XXIV del Purgatorio, vv. 35-63, che parla dei golosi e al v. 55 Bonagiunta Orbiciani da Lucca, a proposito «del suo falso orientamento estetico» dice: «issa (ora) veggio (vedo) il nodo» afferma nodo «che [...] impastoiò [...] quasi tutti i lirici del duecento» e perfino Dante, il quale poi «si distrigò da quel nodo per via di genialità istintiva, non per illuminato ragionamento estetico». Nodo che si riduceva «alla lusinga o alla credenza che a fare arte giovi l'indirizzo o la ricetta». Lo Schilirò, quindi, fa la cronistoria della nostra lirica che, «fatta eccezione per qualche canto siciliano d'amore e per gli slanci mistici del Poverello di Dio, è versaiuolismo d'imitazione». Vedi la letteratura cavalleresca e la poesia amorosa dei Provenzali. Il primo intoppo alla nostra lirica bambina - continua lo Schilirò - è stato precisamente un assillo di coscienza: la inconciliabilità tra fede e sentimento. [Ma] dalla dotta Bologna, centro di studi filosofici e teologici, partì l'indirizzo pacificatore e tranquillizzante. Guido Guinizelli domandò all'etica cristiana, stupendamente coordinata dall'Aquinate (S. Tommaso), la soluzione del tormento poetico. L'amore, nella morale cattolica, non era condannato, ma voleva essere onesto, beatificante, orientato verso l'amore divino. [...] La canzone A cor gentil ripara sempre Amore, sta come una pietra miliare. L'amore può disimpegnarsi dalle vecchie tradizioni, sia pagane che cavalleresche, e andare di conserva con la fede religiosa. [...] E Cino da Pistoia, Guido Cavalcanti e l'Alighieri - che «salutò il bolognese (Guinizelli) come padre suo e degli altri suoi - si pongono senz'altro sulla nuova via [...] e trovano mirabilmente logica la sublimazione dell'amore e la conciliazione della poesia con la fede». E a proposito di Dante, «il maggiore e più autorevole rappresentante del dolce stil novo» dice: Al di sopra di tutti egli era poeta. E se anche a lui la preoccupazione filosofico-teologica riesce provvisorio impedimento, non è meno vero che principalmente a lui offre il mezzo di tagliare i ponti con gli artifici di marca forestiera e di porsi sulla via della sincerità, via maestra dell'arte. (Il canone dell'estetica di Vincenzo Schilirò). Propone, quindi, lo Schilirò la rilettura del sonetto dantesco della Vita Nuova, Tanto gentile e tanto onesta pare nel quale, dice, ci troverete compendiosamente espressi la mistica concezione amorosa del Poeta, la migliore personalità di Beatrice e «lo stile della sua loda».
E conclude: Il dolce stil nuovo appare in questo modo un preludio (minore ma significativo) di quel poema grandioso che sarà l'immortale arte italiana. Stile di sincerità che canta integralmente la vita: cosciente dei bisogni temporali e ansiosa dell'eterno. Nei successivi numeri de «La Tradizione» ho trovato anche tre poesie del Nostro, intitolate: In cerca di me stesso, Il mio destino e S'aspetti il sole. La prima è intrisa di dolente pessimismo e di ansiosa ricerca, culminanti nell'ultima strofa: In cerca di me stesso
E quando? Quando
s'estinguerà la mia sete?
quando, sparsa la cenere, di questa
soma, al vento, potrò spedito andare
e ritrovare me stesso?
---- Anche la seconda, dopo un inizio sfiduciato, in parte mitigato dal paragone con Gesù-uomo, conclude con una amara constatazione e con un interrogativo: Il mio destino
Andare, andare sempre
è il mio destino:
ma verso quale mèta,
spellandomi le piante
e tutto insanguinato,
mi trascino?
--- Solo l'ultima, che riporto a destra, pur macabra nell'inizio, termina con un verso di fiduciosa speranza:
«Non intristire, no! Risorgerai». S'aspetti il sole...
Un morto se ne va ch'è notte gelida. Oh, com'è duro uscir di casa al buio
e al lugubre stupore delle stelle!
Ed è sì lungo e sì penoso il viaggio,
che non s'arriva mai al camposanto... Dunque non s'è trovato per quel morto
un buco - nella casa che fu sua -
dove fargli passare meno tetra
la prima notte del riposo eterno? lo ho paura del buio e del freddo
notturno. E imploro che, quando la Morte | m'avrà mozzato l'ultimo respiro,
s'abbia di me pietà. Si aspetti il sole
pria di scacciarmi dalla casa mia
ospite inviso. Solamente il sole
risveglia la natura, perché dia
un estremo saluto a chi si parte;
ed insegna la via del camposanto
e suggerisce ai queruli cipressi
di dar conforto e bisbigliare all'ospite
nuovo, già diaccio e sfatto e difformato:
«Non intristire, no! Risorgerai ». |
Dopo aver tracciato e documentato la dodicenne vita de «La Tradizione» e aver visto Vincenzo Schilirò nelle sue diverse funzioni di redattore, di condirettore per la sezione Letteratura e poi di direttore unico, e nel suo ruolo di storico, di filosofo della religione, di modernista, di critico letterario ed estetico, siamo arrivati alla sua natura primigenia di poeta. E chiudiamo, riportando il suo «congedo» per la cessazione delle pubblicazioni della Rivista, nel quale esprime il suo «rammarico per il bene che essa avrebbe potuto continuare a fare», fiducioso, però, nella «Provvidenza». Accennando, quindi, alle «condizioni di isolamento degli scrittori cattolici e alla diffidenza della cultura laica nei loro riguardi» afferma che la Rivista «ha avuto uno scopo e può vantare dei notevoli successi» che saranno perseguiti dai «tanti gregari che da essa hanno attinto energia e spirito di solidarietà»; Auspica aiuti dal Cielo più che dagli uomini» perseguibili con la preghiera, augurandosi il sorgere di «altra iniziativa di intellettuale apostolato [...] per la grandezza della patria e della civiltà cristiana».
| [2] Negli ultimi due capoversi si vede uno dei due aspetti del suo Modernismo, oltre quello sociale. |