 «Facendo solecchio» (come inizia Vincenzo Schilirò il suo saggio su Pirandello) mi piace incominciare questo mio ricordo del grande Brontese; uomo integro, prete modernista rispettoso prima delle sue oneste convinzioni e poi delle disposizioni della Chiesa di cui accetta l'emarginazione imposta da papa Pio X, conservando, però, fino alla morte, l’abito talare a testimonianza del suo sacerdozio; letterato che spazia dalla letteratura italiana alla filosofia, dalla critica alla poesia, dalla sociologia all'estetica e alla drammaturgia. «Facendo solecchio» (come inizia Vincenzo Schilirò il suo saggio su Pirandello) mi piace incominciare questo mio ricordo del grande Brontese; uomo integro, prete modernista rispettoso prima delle sue oneste convinzioni e poi delle disposizioni della Chiesa di cui accetta l'emarginazione imposta da papa Pio X, conservando, però, fino alla morte, l’abito talare a testimonianza del suo sacerdozio; letterato che spazia dalla letteratura italiana alla filosofia, dalla critica alla poesia, dalla sociologia all'estetica e alla drammaturgia.
Vincenzo Schilirò nacque a Bronte il 7 gennaio 1883, studiò nel Real Collegio Capizzi fino al 1898 conseguendo la licenza ginnasiale col massimo dei voti. Vocato alla vita religiosa, prosegui gli studi presso il Seminario Arcivescovile di Catania dove il 22 dicembre 1906 fu consacrato sacerdote dal cardinale Francica Nava. Negli anni seguenti, secondo la testimonianza di mons. Salvatore Sanfilippo, «fu cappellano nella Chiesa di S. Antonino in Bronte; richiamato per imprecisate questioni, assieme ad altri sacerdoti, dal cardinale Francica Nava, ne uscì completamente pulito».[1] Non frequentò l'Università, ma nel 1912 consegui presso l'Università di Catania la laurea in Lettere; laurea che però fu una specie di giallo, perché la sua tesi sulla Credenza carducciana non fu giudicata «farina del suo sacco» (proprio come adesso che molti laureandi comprano la tesi bella e stampata!) e dovette essere confermata da una tesina integrativa (Il Romanticismo e gli amici pedanti) che fugò i sospetti della Commissione giudicatrice e del relatore prof. Savj Lopez. Lo Schilirò accettò subito di andare a insegnare al Collegio Capizzi della sua città, dove continuò i suoi studi e la sua produzione letteraria, a favore specialmente dei più deboli e dei meno capaci. La sua attività si orientò prima di tutto verso il campo didattico-educativo con l’Arte poetica di Orazio Flacco a cui fanno seguito La credenza carducciana e il suo valore con un intermezzo poetico, Primavera triste a cui segue Il Romanticismo e gli amici pedanti, pubblicati tutti nel 1912. Seguirono poi nei 1918 I motivi estetici dell'arte d'annunziana e quindi nei 1919 Il colpevole (dramma) e F. T. Marinetti e il Futurismo. Nel 1920 pubblicò Note dantesche e nel '21 Bricciche letterarie a uso delle scuole.
Nel 1923 dette alle stampe Il seminatore che non miete (racconto lirico), nel '24 (con la riforma Gentile) Appunti di estetica e nel '26 Santo Francesco (poemetto drammatico). Mentre nel 1929 pubblicò Nozioni di letteratura, sempre per le scuole. Nell’anno scolastico 1928-29 Vincenzo Schilirò non compare fra i docenti del Liceo Capizzi dove è sostituito dal prof. Domenico Magrì, che poi sarà suo recensore, uomo politico di spicco della Democrazia cristiana, senatore della Repubblica e sottosegretario alla Pubblica istruzione.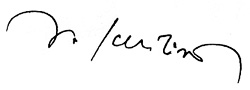 Vincenzo Schilirò (a destra una sua firma) ritorna per l'ultimo anno di insegnamento al Capizzi nell’anno scolastico 1929-30.
Il motivo della suddetta assenza di un anno dal Liceo di Bronte va attribuito, oltre che alle sue precarie condizioni di salute, anche al fatto che nel 1928 fu fondata da Pietro Mignosi, a Palermo, la rivista «La Tradizione» alla quale lo Schilirò cominciò a collaborare fin da allora e fino alla cessazione delle pubblicazioni avvenuta nel 1939. Altro motivo per cui Vincenzo Schilirò si assentò dal Liceo Capizzi di Bronte fu l'acquisto del suolo e la costruzione della sua villetta di via Morosoli, 5 in Catania. Nel 930 avvenne il definitivo ritiro dalla sua attività di docente a Bronte e iniziò la sua libera attività di scrittore a Catania, dove vivrà fino alla morte (1950). Il suo impegno a Bronte non fu solo quello di insegnante e di studioso prolifero, ma anche quello di stimolatore della vita sociale e produttiva: infatti fu il fondatore e il direttore della Filodrammatica del Collegio Capizzi [2], in cui coinvolse parecchi professionisti; fondò una tipografia, che denominò Stabilimento Tipografico Sociale (STS) e che fu quello in cui stampò tutte le sue opere scritte a Bronte; fondò la Cassa Agraria per finanziare le attività agricole e artigiane del paese, e un Circolo culturale per stimolare il desiderio di sapere della popolazione brontese. Aderì con entusiasmo al Partito popolare, fondato da don Luigi Sturzo, dando vita in tempi successivi, a quattro giornali locali: «Il Propagandista», che ebbe vita breve, «Domani!», politico-amministrativo che durò fino allo scoppio della grande guerra del 1915-18, «U Trabanti», umoristico-satirico del '13 che pubblicò solo 4 numeri; mentre il quarto, fondato nel 1920, «Nova Juventus» era il bollettino del Collegio Capizzi, redatto in parte dagli stessi alunni. I primi tre di questi giornali presto dovettero sospendere la pubblicazione per le idee «moderniste in essi esposte e diffuse; [...] con la cessazione di quei periodici lo Schilirò s'allontana definitivamente dalle competizioni politiche e dall'attività sociale, per darsi tutto allo studio, alla scuola e all'arte».[3] Dopo il lungo periodo brontese di attività didattica, letteraria, drammaturgica, giornalistica, sociale e politica, il nostro, come detto sopra, si ritirò a Catania dove si dedicò esclusivamente alla sua libera attività letteraria pubblicando nel '31 Il Carroccio, Dramma milanese e la seconda edizione di Santo Francesco e chiudendo, così, le sue pubblicazioni presso lo Stabilimento Tipografico Sociale di Bronte. Nel '32 pubblica a Catania la seconda edizione dei suoi Appunti di estetica con il titolo Arte = Vita e nel '33 Dall'anarchia all’Accademia, Note sul Futurismo, un libro agiografico sul Venerabile Ignazio Capizzi [4], fondatore del Collegio di Bronte, dal quale sono usciti molti apprezzati professionisti di tutta la Sicilia Orientale, e Schemi di concezioni storiche. Nei 1934 pubblicò le liriche Il pozzo di Sichem, nel '35 il saggio critico Come vedo Pirandello. Altro anno fondamentale per l'attività artistica dello Schilirò fu il 1936, in cui avvenne la conoscenza con Ada Negri e la sua decisione di scrivere un saggio sul percorso spirituale e poetico della poetessa di Lodi. Nel '37 pubblica i tre volumi della Divina Commedia, con una chiara e pregevole versione in prosa, e la seconda edizione di Come vedo Pirandello. Nel 1938 esce a Milano il suo saggio L’itinerario spirituale di Ada Negri e la seconda edizione de L'arte di Gabriele D'Annunzio. Nei 1939, a conclusione della vita de «La Tradizione» da lui diretta negli ultimi due anni, dopo la morte del fondatore Pietro Mignosi, esce l'Antologia Mignosiana.
Sono del 1940 due saggi, Nicola Spedalieri e la sua concezione del diritto e Il fondatore della Compagnia di Gesù, quest'ultimo del filone agiografico. Nel 1941 pubblica un «racconto per giovani»: Gioventù in cammino e nel '43 il suo ultimo saggio critico L'epilogo della tragedia leopardiana. Questo suo lavoro ebbe scarsa eco perché uscì nel periodo più torbido della seconda guerra mondiale con l'occupazione della Sicilia. Del 1945, a Italia liberata e al ricostituirsi dei partiti politici democratici, sono le sue tre opere di sociologia e cioè: Sintesi dell'evoluzione storica del problema sociale, Autonomia e Libertà e Democrazia, che trattano rispettivamente: del problema sociale come era stato affrontato dalla Chiesa di Leone XIII; dei centri amministrativi locali (Comuni, Province e Regioni) in contrapposizione al vento di fronda che spirava in quel periodo di ritorno alla democrazia, dopo il ventennio fascista; e del programma della Democrazia cristiana, sorta dalle macerie del vecchio Partito popolare fondato da don Luigi Sturzo. Quest'ultimo lavoro, letto oggi, rappresenta proprio quel "libro dei sogni" che non si sono avverati, ma che, al contrario, sono stati delusi dalla classe politica che fu proprio l' opposto di quella che andava ipotizzando nel suo libretto il "puro" Vincenzo Schilirò. Nel 1946 fu pubblicato il saggio critico Carducci pedante e credente che praticamente è l'aggiornamento (quindi la terza edizione) dei suoi saggi giovanili sul grande poeta classico. E nello stesso anno vide la luce il secondo romanzo del nostro dal nome straniero Iadwiga, concepito e scritto in pieno regime fascista che, però, non ne permise la pubblicazione. Nel 1948 escono le seconde edizioni de Il pozzo di Sichem (liriche) e de L'itinerario spirituale di Ada Negri con l'aggiunta di lettere inedite della poetessa allo Schilirò. Le lettere di lui alla Negri si trovano presso l'associazione "Poesia, la vita!" di Lodi e sono una ricca fonte di notizie atte a farci conoscere meglio il pensiero del nostro sul movimentato periodo del Modernismo e sulla poesia e la critica cattolica dell'epoca. Due anni dopo, nel 1950, il male che lo minava da tempo lo strappò ai suoi studi e alla sua vita quasi monastica, vissuta nella sua casa di via Morosoli, 5 in Catania, e le sue spoglie furono inumate nella cappella di famiglia nel Cimitero di Bronte.[5] |