

Un paese del Sud - Realtà e fantasia
Il libro di Firrarello di Nicola Lupo “Un paese del Sud – realtà e fantasia” di Pino Firrarello, è stato ripubblicato e distribuito gratis certamente in vista delle prossime, anche se non tanto, elezioni, come giustamente ipotizza qualcuno; ma a prescindere da questo fine non dichiarato, ma legittimo, un uomo politico dalla ormai lunga carriera, avrebbe potuto e dovuto scrivere qualcosa di più e di meglio per rendere conto, ai suoi elettori in continua crescita, e a chi vorrebbe conquistare alle sue idee, di quanto ha realizzato per la comunità in campo sociale. Ma venendo al libretto in sé, di cui si prevede la ristampa fino al 2008, e se dobbiamo condividere la realistica ipotesi dell’autore della Premessa, G. Giarrizzo, secondo la quale “il testo, pubblicato negli anni ’80, sia stato redatto negli anni ’60 […] e che le interpolazioni, se tali sono, appartengono invece agli anni ’80, una volta che Firrarello scelse di pubblicare lo scritto”, si potrebbe dire che l’autore avrebbe fatto meglio se, utilizzando tutti gli elementi oggettivi, frammisti alle “fantasie” che cita nel sottotitolo, avesse riscritto il tutto di sana pianta, adattandolo alla realtà degli anni ’80 e aggiornandolo oggi a quella attuale, alla luce delle molteplici esperienze politiche che ha fatto in un quarto di secolo. |
Il testo è suddiviso in otto capitoletti, seguiti da Colloqui d’emigranti, che dovrebbe essere la parte riferentesi alla “fantasia”, del sottotitolo. Il primo capitoletto, Il paese, vorrebbe gettare le basi storiche dello stesso, che ha origini recenti ed è praticamente “la corte” che si sviluppa attorno al castello del feudo del marchese Trigona: quindi, a fine ‘700, siamo ancora in pieno medioevo! Interessante il secondo, Il cittadino, dove parla anche di “quella mafia rurale, ignorante, impenetrabile” […], che, dice bene il Firrarello, veniva da fuori; esattamente dalle province occidentali della Sicilia, tanto che io ricordo che la nostra provincia di Catania veniva definita “‘a provincia babba”, nel senso di babbea in quanto incapace a imporsi con la forza e con la prepotenza.
Ora, grazie a Dio!, la mafia si è civilizzata e specializzata: non è più quella “di campagna” che era nata per coprire la mancanza di Stato, ma quella di città e delle metropoli, e si è infiltrata in tutte le attività umane, dalla politica ai lavori pubblici, dalla finanza allo spaccio di droga, dalla prostituzione al commercio dei bambini, come possiamo constatare ogni giorno dalla lettura dei giornali e dalle cronache giudiziarie. | 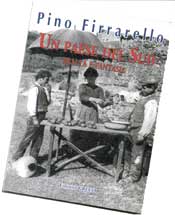 | Un paese del Sud è stato presentato a Bronte il 30 Dicembre 2004 |
|
|
Il terzo capitolo, La scuola, dice praticamente che essa non esisteva tanto che all’inizio dell’ ‘800, sapevano leggere e scrivere solo sei cittadini su 900 abitanti, che costituivano la classe intellettuale a cui doveva rivolgersi il popolino analfabeta. In seguito fu mandato un maestro che ebbe il compito di istituire solo una prima per insegnare a leggere e scrivere perché “bastava che riuscisse ad apporre la firma sulle cambiali, ritenute già lo strumento necessario del futuro.” “La medicina ufficiale non ebbe per molto tempo diritto di cittadinanza a S. Cono” e questo incipit al quarto capitolo, titolato appunto La medicina, riassume quanto verrà esposto in seguito a proposito della salute o meglio delle varie e infettive malattie che venivano curate empiricamente o con la preghiera. “Nessuno aveva notizia di medici e medicine […] Intorno agli anni trenta (di quale secolo il Firrarello non lo dice, ma si presume che sia il ‘900 ) arrivò a S. Cono un medico…” del quale “le persone diffidavano…” ma che col tempo “riuscì a penetrare profondamente nell’animo popolare e somministrare i primi farmaci prodotti dall’industria chimica. Tra questi, uno dei primi e certamente il più famoso fu il chinino, rimedio efficacissimo contro la malaria.” La donna, argomento del 5° capitolo, racconta che all’epoca per essere rispettata “doveva essere madre: la donna senza figli equivaleva ad un albero senza frutto.” Il matrimonio “significava famiglia e rispetto sociale […] il resto era sacrificio.” La gravidanza ed il parto erano gestite da “altre donne abili per esperienza propria”, onde nacque il termine mammana. “Al medico fu precluso di occuparsi delle gestanti.” La donna doveva essere sottomessa e rispettosa, doveva considerare le fatiche piacevoli, non doveva avere conoscenze e seguire le massime: “sbagliando si impara e la vita è maestra.” Vigevano i più assurdi principi morali secondo i quali l’onore di una famiglia e in primis del suo capo, era “profondamente nascosto sotto la gonna della figlia” e da questo principio scaturiva il cosiddetto delitto d’onore, (ora cancellato dal codice!) “con morte finale e poca condanna”. L’autore riferisce diversi casi e infine parla della prima studentessa, una certa Rosaria, la quale dopo le elementari, riesce ad ottenere dal testardo padre il permesso di continuare gli studi. Manca, però, l’ indicazione del fatidico anno scolastico. Il 6° capitolo parla de I pettegolezzi che si svolgevano nella “bottega del fabbro ferraio Don Tano…che ferrava i cavalli e aggiustava gli arnesi, …ma sostituiva anche il veterinario.” I temi dei pettegolezzi erano le donne, le guerre e l’ agricoltura. E vi erano personaggi specializzati nei diversi argomenti, i quali raccontavano a ripetizione le loro esperienze amorose, belliche o lavorative nei campi. Il terrore, argomento del 7° capitolo, parla della seconda grande guerra ‘40/’45, “la cui inutilità, prima a livello di dubbio, diveniva ogni giorno realtà” e in particolare parte dal giugno del 1943, quando “per la prima volta si vedeva circolare un automezzo (la jeep di un colonnello tedesco) e per la prima volta, oltre le domenicali prediche sacerdotali, una persona intendeva rivolgersi ad una moltitudine. Il discorso si “concluse al grido di Viva il Duce, viva la patria, viva il Re, al quale si associarono Pasquale, il podestà, e il gruppetto dei dirigenti del partito fascista, capeggiato dal suo segretario sig. Costantino La Cola. La folla era muta, perplessa, sgomenta, non capiva […]
Ma da allora ci furono le riflessioni che cominciarono a criticare il fascismo, che, però, reagiva con arresti e “olio di ricino”. Ma nel ’43 era finita la stagione dell’olio di ricino che veniva somministrato all’inizio del ventennio, quando esso doveva ancora affermarsi. Quei discorsi prepararono gli animi ad accogliere gli Americani come liberatori e distributori dei terreni dei feudatari. L’8° capitolo parla de La delusione che seguì alla disastrosa guerra e alle prime riforme, specialmente quella agraria, che fecero sorgere il separatismo siciliano e l’affermazione della mafia, entrambi contrastati dai sindacati. E qui l’autore si diffonde nel racconto dei fatti e dei personaggi locali che portarono alla delusione, appunto, e alla fine della civiltà contadina e al risorgere del fenomeno emigrazione degli anni trenta. Nei Colloqui di emigranti, infine, narra, forse con molta fantasia, dell’emigrazione di cinque giovani irrequieti e schizzinosi, i quali, dopo le loro esperienze sessuali “nel casino di Caltagirone”, partono per l’ America in cerca di libertà e benessere. Dopo una traversata lunga e disagiata, Nicola scompare nel grande porto di New York, gli altri quattro vengono mandati in Pensilvania, dove lavorano in miniera e la sera nelle loro baracche di legno devono prepararsi il pasto e fare tutte le altre faccende di casa. Santo, che era scapolo, dopo un po’ di tempo la sera si eclissava perché aveva conosciuto una ragazza francese, Anne; Raffaele conobbe Evelin e, dopo tormentate notti al ricordo della moglie e dei figli, la seguì; Cataldo, che era un fatalista, soffrì per la decisione dell’amico, ma si costruì una casetta di legno per richiamare la famiglia; ma un triste giorno morì sotto una valanga assieme ad altri operai; Orazio, che era l’unico superstite, curò le misere esequie dell’amico e, passati i cinque anni previsti dal contratto d’ingaggio, ritornò al paese. “Il gruppo non esisteva più. Ognuno aveva vissuto la sua realtà.” Segue un affastellamento di riflessioni, poste in bocca a quella povera gente di paese, che culmina con “corsi e ricorsi” posti in bocca alla vecchia Rosalia la quale vuole dissuadere l’unico figlio Rocco dall’ emigrare, ma che finisce col dire: “Non insisto, so di non avere il diritto, vai avanti, Rocco mio,; soprattutto è importante credere nelle proprie scelte e non oscillare come le spighe di grano al vento di maggio.” Che dire della edizione? L’editore Greco, con un buon proto, avrebbe potuto rabberciare il tutto. Ma la propaganda non va per il sottile: tanto chi riceve l’omaggio, che non legge, è orgoglioso che quel politico si sia ricordato di lui e, quindi, lo voterà se non altro per riconoscenza, et hoc erat in votis! Nicola Lupo
Dicembre 2004 |