 VEN. IGNAZIO CAPIZZI VEN. IGNAZIO CAPIZZI
Padre Antonio Messineo, altro illustre Brontese, su «La Civiltà Cattolica» del novembre 1933, presenta il Ven. Ignazio Capizzi, fondatore dell'omonimo Collegio di Bronte, scritto dallo Schilirò per «pagare il debito che lo lega al Collegio per l'istruzione ricevuta» in esso. Il lavoro è «un modesto rapido profilo di un uomo eroicamente umile», chiamato dal pontefice Pio IX «il S. Filippo Neri della Sicilia». Così ne parla il suo concittadino padre Antonio Messineo di «La Civiltà Cattolica»: V. Schilirò, Ven. Ignazio Capizzi, SEI, Torino 1933, in 16°, 162 pp., L. 3,50.
Questo libretto è un vero piccolo gioiello d'arte descrittiva. Raramente si incontra nell'ampia letteratura agiografica dei nostri tempi un profilo di santo abbozzato con tanta intuizione e penetrazione psicologica, interno calore e squisita cesellatura linguistica.
L'A. non ha inteso darci una compiuta biografia del grande apostolo, chiamato dal pontefice Pio IX il S. Filippo Neri della Sicilia, ma «un modesto rapido profilo non disdicevole forse a un uomo eroicamente umile».
La narrazione scorre, quindi, agile, fluida e piacevole, senza quegli indugi sui piccoli episodi e sulle minute cronologie, che sogliono appesantire l'andare di tali descrizioni, se non sono maneggiati da una mano maestra.
All'A. veramente non sarebbe mancata la lena per un simile lavoro, ma egli ha voluto mettere in rilievo, con fine intuito, quei tratti della travagliosa vita del Capizzi, che più giovano a disegnare la fisionomia, a fame comprendere il carattere adamantino, a spiegare il mistero di un fanciullo, che corre attraverso le ariose campagne, dietro il gregge dei suoi agnelli e si solleva poi, gradino per gradino, soffrendo e beneficando, alle altezze di una santità eroica, alle sublimi dedizioni di un apostolato sacerdotale «tutto fervore di spirito e di bene, che impersona l'annullamento di sé e l'amore degli altri». Il ch. Schilirò ha con questo libretto degnamente pagato il debito che lo lega ai Capizzi, per l'istruzione ricevuta nell'istituto, eretto dal santo sacerdote in Bronte, sua città natale, «uno dei principali semenzai della cultura siciliana: non soltanto foro della lingua latina, come lo chiamò Ruggero Bonghi, ma principalmente magnifica palestra di cristiana e civile formazione». (P. Messineo) [1]
 SCHEMI E CONCEZIONI STORICHE SCHEMI E CONCEZIONI STORICHE
Di Schemi e concezioni storiche (dello stesso anno 1933) ho trovato questa recensione autografa inedita di Antos: Sono appunti - come dice l'Autore nella breve prefazione - d'una conversazione, dove fu necessario chiarire che lo storicismo non può fondarsi su alcun sistema filosofico; perché nessuno può fissar - con cognizione di cause - il principio e la vita delle cose. Solo la concezione cattolica dà la soluzione dei problemi della conoscenza così, che la mente umana se n'appaghi. [13.3.1944. L.]
 IL POZZO DI SICHEM IL POZZO DI SICHEM
Dopo Primavera triste del 1912 e Il seminatore che non miete del 1923, lo Schilirò pubblica, nel 1934, Il pozzo di Sichem, magistralmente recensito da padre Domenico Mondrone S.J. ne «La Civiltà Cattolica» del settembre 1934. In questa terza e ultima raccolta di poesie il recensore vede nello Schilirò «un tenace della tradizione, non dei clichés tradizionali [nel quale] pare che la sua norma sia quella di fondere con spirito nuovo i buoni elementi dell' arte poetica antica». |
|
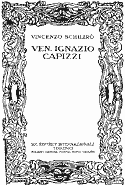
[1] «La Civiltà Cattolica», 18.11.1933.

| Ma leggiamone per intero la recensione: Ultimo, ed in buon punto, ci giunge un bel volume di Vincenzo Schilirò.[2]
Avversario dichiarato del vacuo «astrattismo» prediletto da certi lirici moderni, questo siciliano porta invece nella sua poesia il contributo di tutto l'uomo: intelligenza, immaginazione, sensibilità artistica. Ogni sua lirica è avvivata da un pensiero, colto secondo aspetti per lo più originali ed espresso ora con estrema semplicità, ora mediante un carico sovrapporsi di colori, da far pensare ai capricciosi e sgargianti ghirigori di certi frascami arabeschi.
Ma soprattutto c'è aria, c'è luce ed olezzar di agrumeti: una poesia che offre un buon documento di sincerità nel caratteristico sapore che ci porta della sua terra.
Si avverte subito, nello Schilirò, un realismo così rettamente umano, da prendere, quasi senza volerlo, un carattere, più che un semplice indirizzo, schiettamente religioso e morale. Segno che l'A. ha una consumata attitudine a raccogliersi sui fatti, talora più modesti ed inosservati, della vita, guardarli direttamente in profondità e trarne significati aderenti alla nativa dirittura della sua anima e spontaneamente conformi alla sana e religiosa comprensione dell'arte.
Chi legga Chiesetta montana, Nulla e tutto, Fantasie, Poter sognare, Calen di marzo, La luce del Signore, Vigilia, s'accorgerà facilmente che c'è vera aria di novità.
Questa novità è contraddistinta, tra l'altro, da un suo particolare intento conciliativo tra la poesia ortodossa e la nuova, sia per ciò che riguarda la questione del contenuto, come per le forme metriche. Lo Schilirò non vuol essere un novatore garibaldino, rivoluzionario; ma neppure vuol ristagnare troppo nel passato. Tenace della tradizione, non dei clichés tradizionalisti, pare che la sua norma sia quella di fondere con spirito nuovo i buoni elementi dell'arte poetica antica. Ma egli è interamente riuscito nel suo intento?
Tra i demolitori del passato ed i fautori di novità da non prendersi affatto sul serio, il poeta vero, geniale, rappresentativo, che possa assidersi tra le due sponde, purtroppo ancora non si vede spuntare sull'orizzonte della nostra poesia.
Ora, tante belle impressioni destate dal libro dello Schilirò sono spesso attenuate dall'abuso d'un frasario piuttosto ricercato, da modi abbastanza prosaici e ineleganti, e da immagini d'una certa "virtuosità" secentesca.
Quanto gli effetti metrici, sebbene l'A. non sappia rinunziare, e fa bene, «all'armonia nascente dall'accento ritmico», ottenuta col saper «abilmente fondere e variare i versi tradizionali», ed atta a «dare alcunché di quell'armonia interiore che è l'armonia del momento creativo», tuttavia l'orecchio non ha saputo accomodarsi al suono di parecchi tratti, dove difficilmente si riesce a percepire una gradita espressione ritmica, anche se cercata in tutto il giro d'un periodo strofico.
Oggi si parla spesso di un'armonia intesa come elemento lirico interiore; ma se questo si vuol comunicare ad altri, è impossibile fare a meno di una regolata espressione metrica della strofa, che ne è appunto il veicolo esterno. Se è vero che l'arte è pazienza, forse bisognerà ancora studiare per scoprire la legge metrica, che governi, con più fortuna di risultato, il ritmo accettabile della strofa nuova. Ma anche in ciò, messa da parte ogni astrusità metafisica, bisogna ritenere come prima e più elementare norma d'una buona armonia: quod auditum placet. (P. Mondrone)[3] Ma eccone la recensione inedita di Antos: Il pozzo di Sichem Pur questo volume di versi: Il pozzo di Sichem (La Tradizione, Palermo 1934), spunta dopo un notevole intervallo. Ma, questa volta quante esperienze non si sono accumulate dalla febbrile attività letteraria del dopoguerra!
Sembra però curioso: lo Schilirò, proclamatosi già energicamente «antiletterario», in un articolo di «La Tradizione», dà poi qui le prove più folgoranti delle ricchezze di lingua e di stile acquisite da quelle attività a cui egli, sensibilissimo, non poteva naturalmente rimanere estraneo; anzi, talora - nonostante l'espressa dichiarazione nella quasi prefazione «A scanso di equivoci» - pare scivolar addirittura nel futurismo.
Ma non inutilmente ho parlato di esperienze. Se il libro si legge una seconda volta, ogni apprensione cade, e il lettore si trova dinanzi al poeta.
Non tutto, certamente, potrà appagare ogni lettore. C'è chi piglierà tutto il volume per pura poesia - non dico poesia pura -; c'è chi vedrà in certe poesie il critico, il quale non fa qui il processo a un altro poeta, al D'Annunzio, per esempio; in certe altre vedrà il poeta, che canta il mondo dell'anima sua. Il secondo forse si troverà più a suo agio, quando vorrà riprendere gli toccherà spesso il volume. [6.11.1944. L.] Il titolo è suggestivo. Non solo riconduce la mente alla fonte inesauribile, che spegne la sete a quanti vi ricorrono, ma anche a quel pozzo dove Gesù trovò il ristoro alla sete di anime; una idea e l'altra s'avvicendano e s'illuminano e qui è la genialità di molte di queste 58 poesie in cui il Poeta fa risonar le corde più delicate dell'anima sua e in cui ogni lettore avverte in sé l'eco misteriosa, propria dell'arte. Prendere, per esempio, la prima: Il pozzo di Sichem. Essa è già, più che specie di prefazione, una fonte donde zampilla il sorriso di tutte le altre poesie.
L'occhio del Poeta - e l'occhio, l'anima - si protende ansioso, estatico, quello «della suora di Lazzaro» per seguire Gesù lungo il cammino «ahi! lungo, polveroso, riarso / nel sole a picco».
E, dove passa Gesù, egli negli immensi campi di «bionde spighe, che riflettono sù, la sua biondezza»; vede i calcoli affannosamente umani di Giulia e di Filippo, speranzosi nel guadagno e nel pane, e la tacita risposta degli occhi di Gesù: «Un altro, un altro è il pane che satolla!» spunta allora la Samaritana, che dà a Gesù l'acqua del pozzo e riceve l'acqua, che l'anima disseta in sempiterno. Una visione veramente da estatico si riflette in ogni anima, la quale sente dati per sé gli ultimi candidi versi: «O donna dai cinque mariti; / o folle arsura, che invano attingevi / dal pozzo dei padri, e poi che trovasti la fontana viva, / orsù cammina / e ad essa guida / la triste torma dagli assetati». L'ampiezza del respiro è pari alla visione e il canto dà la misura del verso, che - ben dice, con coscienza, il Poeta - «è verso» e non altra manifattura in voga ai nostri tempi. Il quadro è breve; e questo mi fa pensare al De Vigny, parco nelle parole e nei versi da parer quasi povero d'espressione dinanzi al magniloquente Hugo, ma più preciso, più intenso nella visione, dove l'anima sembra perdersi. Confrontate il primo poemetto del Vigny-Moise con la poesia dello Schilirò, che ho brevemente illustrato e ch'è pur essa un poemetto, e vedrete quasi la medesima anima, che, in una eterea solitudine, cerca dissetarsi. Non importa qui il confronto dell'un poeta, che, non credente, va a dissetarsi nella morte, con l'altro, che, credente, va a dissetarsi nel «pozzo di Sichem». Questa considerazione spirituale non offende quel confronto, che ho voluto far io, ma non so s'abbia una ragion d'essere nella mente dell'artista. Il quale non si è accorto nemmeno che, sol nel suo modo d'esprimersi, c'è qualcosa - qualche piccola cosa -, che rimane dallo studio del D'Annunzio, pur da lui tanto tenuto a bada, e dal Pascoli, tanto da lui ammirato e finanche difeso (in Bricciche letterarie). Fortuna però che, nell'uno e nell'altro caso, l'espressione è vivificata dal soffio che avvisa tutta una poesia. E questo soffio viene dall'anima del Poeta, che dovunque rissa l'occhio vede e canta.
C'è - come ho accennato - dove una visione attira più il pensiero e, quindi, fa pensare al critico; ma non si leggeranno mai abbastanza molte altre poesie, che fanno sentire i palpiti del Poeta e muovono quelli dei lettori. Eterna umanità. Leggete: Mani sudice; Vagabondo e mattiniero; Il mio pane; Sii buono; Più su; Primavera; Malinconia e altre simili.
Qui il Poeta, con l'anima dolorante e protesa nell'infinito, piange, sì, il dolore che serpeggia nella vita; sente l'angoscia della vita. che non vuoi morire e pur vola rapidamente; ricorda la giovinezza che diede tante speranze e non è più; sente l'ombra della morte, che pesa allo sguardo e al cuore; ma di tutti questi sentimenti sa l'armonia di un canto, che s'eleva a una vita più bella e duratura. «Rimira i prati / ora ch'è sciolto il gelo / e la nebbia è sparita. / Vedi? la terra, che i semi seppellì e li disfece / non soffocò, / moltiplicò la vita / e anche i chicchi caduti / del nostro tempo I l'Agricoltore eterno / moltiplica all'infinito / nel suo giardino fiorito.» (Non è morto) Ma c'è soprattutto L'aquilone, dove il Poeta rievoca con immensa gioia dei suoi trastulli puerili, più caro tra tutti quello dell’aquilone che oggi gli risveglia desideri più alti e intensi: «Tutto / il filo del mondo ti allento. / Ascendi, / occhiata che avrai la tenda plumbea, / di là risiede l'azzurro e l'infinito». E sta in questo gemere ansioso se il soffio, che - come dicevo - avviva l'unità a tutti i canti di questo volume e fa fare certi nei, che trovano la loro origine nella cultura classica del Poeta, nel D'Annunzio e nel Pascoli. [10.11.1944. V.)[4] |
| 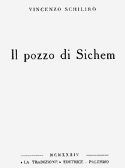
[2] Schilirò, V., Il pozzo di Sichem, La Tradizione, Palermo 1934,140 pp., L. 10.
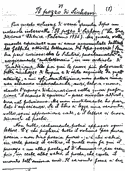
Il pozzo di Sichem, la recensione inedita di Antos
[3] «La Civiltà Cattolica», 1.9.1934.
|
 COME VEDO PIRANDELLO COME VEDO PIRANDELLO
Nel '35 esce Come vedo Pirandello in cui si evidenzia il dissidio critico tra lo Schilirò e il suo giovane amico Pietro Mignosi sulla religiosità del drammaturgo siciliano dal Mignosi asserita, ma negata dallo Schilirò. Su questo saggio critico ecco cosa scriveva al nostro la Negri: «il suo libro su Pirandello [...] è di una acutezza mirabile e in tante osservazioni e deduzioni mi sembra abbia assolutamente ragione. A me ogni opera pirandelliana è stata sempre cagione di oscura sofferenza, senza spiraglio di conforto. Ma egli fu la prima vittima del suo genio tormentato». E lo scrittore di «La Civiltà Cattolica» scrive: V. Schilirò, Come vedo Pirandello, SEI Torino-Catania 1937 (seconda edizione), in 8°, 144 pp., L. 7. Salutiamo con vivo compiacimento la seconda edizione di questo libro di disamina giudiziosa ed oggettiva, che l'A. ha condotta sul grande commediografo, in risposta al volume di Pietro Mignosi Il segreto di Pirandello. E noto come nel libro dello Schilirò vengono esaminate le posizioni ideologiche, estetiche ed areligiose di Luigi Pirandello; ed è noto pure con quanta unanimità di consensi fosse accolta la prima edizione di questo libro, quando il Mignosi gettò sul tappeto la sua tesi in favore della religiosità del grande commediografo.
Ora che attorno alla improvvisa scomparsa di quest'ultimo, quelle discussioni si sono alquanto riaccese, il libro dello Schilirò si presenta nuovamente opportuno, e con qualche aggiunta sull'ultimo Pirandello. (P. Mondrone) [5] Nel '36 avviene l'incontro ufficiale con Ada Negri: lo Schilirò scrive un «compendioso articolo» sulla Poetessa, pubblicato su «La Tradizione» ed Ella lo ringrazia con queste parole: «Lei penetra e rende benissimo il mio dramma [...] e, dovendo io stessa parlare di me, non avrei detto diversamente». Nel luglio dello stesso anno conosce personalmente la Negri a Pavia e, dopo esserne stato esortato dal Mignosi e dal Casnati, decide di «dare uno sguardo complessivo all'evoluzione dell'arte della Negri sulla scorta del di lei itinerario spirituale».
La poetessa di Lodi ne fu lusingata e gli disse: «Che vogliate occuparvi della mia attività letteraria è cosa che lusinga anche me, perché voi non siete uno dei soliti critici». Fu così che nacque L'itinerario spirituale di Ada Negri, come specificheremo nelle pagine seguenti. In quell'anno (1936) V. Schilirò pubblicò Papà Ottocento e il suo rampollo, composto da «due articoli nati per andare insieme. Il primo dà uno sguardo sommario alla fisionomia spirituale dell'Ottocento, senza riguardi a idoli e a scuole; il secondo, stabiliti i rapporti fra Ottocento e Novecento, richiama l’attenzione sul problema della "sanità e vitalità della letteratura" quale esso è prospettato nel nuovo clima».[6]
 LA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI, ANNOTATA E VOLTA IN PROSA LA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI, ANNOTATA E VOLTA IN PROSA
Particolare attenzione merita La Divina Commedia di Dante Alighieri, annotata e volta in prosa dallo Schilirò, di cui ha riferito su «La Civiltà Cattolica» del luglio 1937 padre Mondrone per l'Inferno, evidenziando in primo luogo che essa è diretta «agli studenti e non ai professori e ai dantisti» e, quindi, anche le note sono «quanto bastano a chiarire il testo. [...] La traduzione in prosa del testo dantesco è molto ben fatta e di grande utilità scolastica», ma leggiamone la recensione completa: V. Schilirò, La Divina Commedia di Dante Alighieri annotata e volta in prosa: Inferno, SEI, Torino-Catania 1937, in 8°, 274 pp., L. 10.
Solo chi passa per la dura esperienza della scuola può intendere con quanta ragione lo Schilirò giustifichi questa sua nobile e ben riuscita fatica.
«Non essendo il poema dantesco di facile e spedita lettura, il giovane, prima ancora di gustarne la bellezza, si sente stanco ed annoiato. Bisogna pur confessare che di tale noia e stanchezza alquanto responsabili sono i commentatori, i quali con la retta intenzione di spiegare bene e largamente la Commedia, finiscono col bardarla ed appesantirla di soffocante erudizione e di chiose spesso arbitrarie».
Di qui la idea di un'edizione, la quale «presentando il poema col minimo di cultura mortificatrice e col massimo di scorrevole chiarezza, riesca a farlo leggere difilato, come si legge un romanzo interessante».
L'A. dirige quindi il suo lavoro agli studenti e non ai professori o ai dantisti; e «del giudizio favorevole degli studenti - dice egli con la spigliata libertà di uomo pratico - sono quasi sicuro». Per il suo intento, l’A. ha ridotto al minimo gli ingombri dottrinali, esegetici e poliallegoristici. Note, quante bastano per chiarire il testo. Appiè pagina c'è la traduzione in prosa del testo dantesco. È il lavoro sul quale abbiamo volta di più la nostra attenzione e lo troviamo molto ben fatto e di grande utilità scolastica. L'edizione è, anche tipograficamente, bella. (P. Mondrone)[7] Per il Purgatorio ha recensito il padre G. Busnelli S.J. ne «La Civiltà Cattolica» dell'agosto del 1938 soffermandosi sulla interpretazione dei vv. 73-75 del canto XXV, perché non la condivide e dandone una sua dotta e puntuale versione.
Eccone la,dettagliata e dotta recensione: Dante Alighieri. La Divina Commedia annotata e volta in prosa da Vincenzo Schilirò. Purgatorio, SEI, Torino 1937, in 16°, 297 pop., L. 10
Fu già da parecchi letterati volto in prosa il divino poema dantesco per agevolarne l'intelligenza agli studenti; al quale scopo anche questa nuova riduzione del prof. Schilirò potrà tornare comoda, come utile n'è il breve commento, sugoso e sufficiente a chi s'appressa a Dante, Minerva oscura di intelligenza e d'arte, per conoscerne il pensiero, qualche simbolo e notizia de' personaggi.
Non ci accordiamo col commentatore nell'intendere al canto XXV, 73-75 come lo spirito nuovo di virtù repleto tiri in sua sostanza ciò che nel corpo animato d'anima sensitiva trova attivo, perché le attività sono molte, tra le vegetative e le sensitive, e Dante non specifica ciò che è attivo, cui trae in sua sostanza. Perché, essendo lo spirito già pieno di virtù non gli manca nessun principio attivo, ma solo ha da tirare in sé quanto di attivo hanno predisposto nel corpo le anime vegetativa e sensitiva, le quali vengono sostituite dalla pienezza di virtù del medesimo spirito, che le tira in sua sostanza, «trahit ad suam substantiam», dice l'Aquinate, in quanto fa proprio termine delle sue virtù vegetativa e sensitiva il risultato delle due anime precedenti, o principi attivi, cui non identifica o immedesima in sé, ma sostituisce, secondo la dottrina aristotelico-tomistica.
Non potrebbe farsi un'alma sola, di due anime corruttibili e d'un'anima razionale incorruttibile; ma si fa una alma sola, perché resta nell'animazione spirituale del corpo ciò che è stato fatto attivamente vegetante e sensitivo dalle anime precedenti congiunto e vivente e vegetante e senziente per informazione dell'anima razionale che ha anche in sé virtù vegetativa e sensitiva, oltre la intellettiva.
Così il calor del sole si fa vivo, in quanto congiunto all'umore preparato dalla vite, come materia attiva, lo tira in sé scaldandolo, e avvivandolo del suo attivo fermento, che sostituisce, facendolo suo, senza identificarlo in sé, il poco calore e la poca attività della vite, cosicché il vino viene insieme a contenere in parte l'effetto del calor del sole, non già la forma del mosto, ma la sua materia attiva originata dalla vite, e tramutata per altra forma.[8] E il Paradiso chi lo ha recensito?
Nessuno, perché manca nella biblioteca de «La Civiltà Cattolica».
|
| [4] Antos, manoscritto inedito.
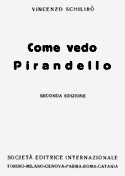
[5] «La Civiltà Cattolica», 17.7.1937.
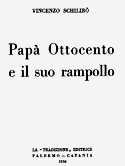
[6] Introduzione a Papà Ottocento e il suo rampollo, La Tradizione, Palermo 1936, p. 3.
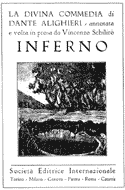
[7] «La Civiltà Cattolica», 3.7.1937.
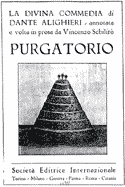

[8] «La Civiltà Cattolica», 20.8.1938.
|
|