 | 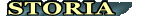
Le carte, i luoghi, la memoria ... |
| L'epidemia di colera, il linciaggio | La Storia di Bronte, insieme |  |
| Ti trovi in: Home-> Storia-> Il colera-> Il linciaggio di F. Scoglio |
Cenni storici sulla Città di Bronte IL LINCIAGGIO E L'AGONIA DI UN INNOCENTE "CREDUTO SPACCIATOR DI VELENI PER PROPAGARE IL COLERA" 1887, il colera a Bronte: "Dagli all'untore!" Il linciaggio di Filippo Scoglio  Da ricerche effettuate negli archivi del Real Collegio Capizzi abbiamo riscontrato che l’episodio raccontato da Eduardo Cimbali nel suo libro "Pregiudizi o gli amici del colera" è più cruento e crudele di quanto appaia. Da ricerche effettuate negli archivi del Real Collegio Capizzi abbiamo riscontrato che l’episodio raccontato da Eduardo Cimbali nel suo libro "Pregiudizi o gli amici del colera" è più cruento e crudele di quanto appaia.
L’incolpevole vittima brontese, malcapitato untore (“creduto spacciator di veleni per propagare il colera” veniva indicato dai giudici della Corte Suprema di Giustizia di Palermo), si chiamava Filippo Scoglio (o Scaglio, come invece riportato negli atti istruttori) sposato con Rosa Mirenda. Fu barbaramente ucciso, dopo due giorni di agonia, il 12 Settembre 1855 nella contrada “Fisacchi” (nei pressi di Contrada Barbaro, sul greto del fiume Simeto), con un atroce accanimento e con modi tanto crudeli e selvaggi da sembrarci incredibili. Fu la povera moglie Rosa ad avvisare il “regio giudice” dell’assassinio del marito Filippo quando, disperata non ne ebbe più notizie e forse avvisata, ma con colpevole ritardo, da qualche animo gentile. E - recitano gli atti istruttori - «recatosi il giudice sul luogo rinvenne il cadavere del miserando Scoglio in istato di putrefazione». I medici legali nominati dal giudice riferirono che la morte di quello infelice era avvenuta per la frattura delle ossa della testa, «e pei guasti nello interno della stessa, prodotta da reiterati colpi di strumento contundente». Un efferato delitto che sembrava uno dei soliti omicidi dell’epoca, ma procedendo ad ulteriori indagini si scoprì ben presto il movente e l’atroce sequenza che aveva portato il povero (“misero” per la gran Corte) Filippo Scoglio al linciaggio da parte di una folla inferocita e, dopo un'agonia durata tre giorni, alla morte. | I fatti sono descritti nella loro sequenza con spietata, asettica, analisi nella sentenza che, il 14 Aprile 1856, la Corte Suprema di Giustizia di Palermo, “sotto la presidenza del cav. Muccio”, emise sul ricorso presentato da uno degli imputati del delitto, D. Filippo Sanfilippo di Bronte, imputato oltre che per correità nell’omicidio anche per i «due reati di vociferazioni sediziose di spargimento di veleno dirette a turbare la interna sicurezza dello Stato e quello della resistenza». Il presidente, cav. Muccio, «pose in chiaro che la mattina del dì 10 settembre (1855) ultimo Antonio Giarrizzo, Vincenzo Sciacca Duchino, e Sebastiano Gangi Tumminello si fecero ad inseguire lo Scoglio lungo il letto del fiume in contrada Barbaro, annunziandolo propinatore di veleno (colera) e raggiuntolo si fecero a percuoterlo con sassi, con bastoni e cozzo di una scure.» Insomma una vera caccia all’uomo, anzi all’untore di manzoniana memoria sospettato di “spargere la peste per mezzo di veleni contagiosi, di malie” per lo più spalmando di sostanze untuose gli usci delle case, spargendo polveri venefiche e simili. Per l’innocente Filippo Scoglio il calvario era appena cominciato, perché – continua il giudice - «Gangi, armato di fucile, l’avrebbe scaricato contro il misero Scoglio, se non fosse stato impedito da un certo Antonio Cordaro Bivacqua accorso alle grida dell’offeso.» Impotente davanti a tanta violenza, il povero Filippo, in un impeto di disperazione e di terrore, trovò la forza per rialzarsi e si diede a fuggire lungo il greto del fiume Simeto, quando lo Sciacca «nelle cui mani era passato il fucile, lo sparò contro detto Scoglio, ma il colpo andò fallito.» Con la forza della disperazione Filippo si diresse, correndo lungo il greto del Simeto come gli consentivano le gravi ferite riportate, verso la contrada Fisacchi ma la sua breve fuga non ebbe fortuna. Ben presto le ultime residue energie gli vennero meno e fu raggiunto “da quei ribaldi (…) che si fecero a lapidarlo crudelissimamente, e lo lasciarono quasi sepolto sotto l’enorme massa delle pietre scagliategli.» Nessuno intervenne per salvare la vita «al miserando Scoglio» che giaceva privo di sensi sulla riva del Simeto, in contrada Fisacchi; nessuno avvisò la forza pubblica, ne tanto meno qualcuno avvisò la moglie Rosa che disperata aspettava a Bronte il ritorno del marito; tutti furono complici di quell’efferato omicidio. Forse la morte di qualche loro congiunto avvenuta per l’epidemia di colera che imperversava all’epoca del fatto criminoso aveva ottenebrato la mente di tutti. L’untore doveva assolutamente morire.  «Risulta eziandio, - si legge nella sentenza emessa sette mesi dopo il misfatto - che in detto luogo ove facevasi tanto scempio, essendo sopraggiunti armati di fucile Filippo Sanfilippo, e Giovanni Furnari, il primo diceva al misero Scoglio di aver pazienza se moriva, perchè aveva fatto morire tante persone, alludendo allo spargimento di veleno e quindi ordinava dapprima di bruciarsi le di lui vestimenta, e poscia ritrattandosi disponeva invece che si frugassero; e rinvenutosi nelle scarselle un pezzetto di carta scritta, diceva a quei villici ch’era carta della cancelleria e questo glielo diceva in modo da far sorgere il sospetto che esso lui, il miserando, fosse un incaricato dell’autorità pubblica donde nacque un sussurro in mezzo agli astanti.» «Risulta eziandio, - si legge nella sentenza emessa sette mesi dopo il misfatto - che in detto luogo ove facevasi tanto scempio, essendo sopraggiunti armati di fucile Filippo Sanfilippo, e Giovanni Furnari, il primo diceva al misero Scoglio di aver pazienza se moriva, perchè aveva fatto morire tante persone, alludendo allo spargimento di veleno e quindi ordinava dapprima di bruciarsi le di lui vestimenta, e poscia ritrattandosi disponeva invece che si frugassero; e rinvenutosi nelle scarselle un pezzetto di carta scritta, diceva a quei villici ch’era carta della cancelleria e questo glielo diceva in modo da far sorgere il sospetto che esso lui, il miserando, fosse un incaricato dell’autorità pubblica donde nacque un sussurro in mezzo agli astanti.»
Sol perché la carta proveniva dalla cancelleria, quindi dall’autorità governativa, (ammesso che fosse vero) sottintendeva un’autorizzazione data a Filippo Scoglio a spargere il veleno del colera. |
| 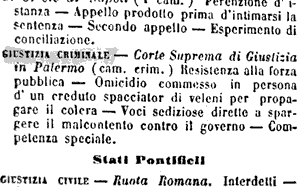
La Gazzetta dei Tribunali, giornale di giurisprudenza e di discussioni giudiziarie – Napoli, 30 Aprile 1859, Anno XIII, Num. 1349 (Distribuzione Mercoledì e Sabato – Uffizio – Strada S. Giovanni in Porta n. 32).
La sentenza del 14 aprile 1856 - scrive il giornale - «è tratta dalla «Legge Applicata, raccolta di decisioni» che si stampa in Palermo, sotto la direzione del Procurator generale del Re presso la C. S. di Giustizia.» |
|

Il Simeto in contrada Barbaro
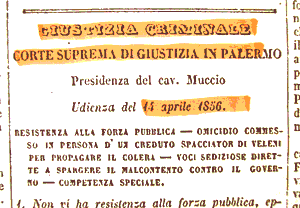
Giustizia criminale - Corte Suprema di Giustizia in Palermo - Presidenza del cav. Muccio - Udienza del 14 Aprile 1856.
DAGLI ALL'UNTORE!
Un episodio simile al cruento omicidio di Filippo Scoglio, avvenne anche a Maletto dove un incolpevole vittima, tale Vincenzo Giangreco, “creduto spacciator di veleni per propagare il colera”, stava per fare la stessa fine. Ecco come racconta l'episodio Il Corriere di Catania (1887). |
|
| Filippo Sanfilippo, come se ce ne fosse bisogno, incitava quindi ancor più i presenti al linciaggio riversando sul povero Scoglio la diffidenza, l’ostilità, quasi l’odio che tutti portavano contro lo Stato borbonico che, fra l’altro, pochi anni prima aveva soffocato con una violenta reazione le speranze autonomistiche generate dai moti del 1848. L’oppressione e la miseria con le quali viveva all’epoca la popolazione brontese erano antiche, secolari; la Ducea dei Nelson e pochissimi altri proprietari terrieri tenevano i terreni più fertili e rigogliosi; nel totale disinteresse delle classi più agiate verso la povera gente, ai contadini, ai braccianti per sfamare la famiglia restavano da coltivare solo pietraie e sciarelle e il lavoro, quando c’era, lo davano solo coloro che avevano terreno da coltivare. E l’ostilità e l’astio verso le classi agiate e contro lo Stato borbonico aumentava sempre più. Sarebbe poi ancora una volta sfociato nel massacro di cinque anni dopo noto (1860) col nome di Fatti di Bronte. Per la poca profilassi urbana e rurale, le periodiche mortali epidemie coleriche (1832, 1848, 1859, 1887) poi avevano dato il colpo di grazia a tante famiglie già stremate dalla miseria e dalla fame. E che il colera lo diffondesse lo Stato era diventato un sentire comune tanto che un articolo del codice penale dell’epoca (art. 142) puniva le “vociferazioni sediziose di spargimento di veleno dirette a turbare la interna sicurezza dello Stato”. Il reato che prima era di competenza delle Commissioni militari, giusta il real decreto del dì 6 agosto 1837, in seguito delle supreme commissioni pei reati di Stato ed all’epoca del fatto dalle gran Corti speciali che vi furono surrogate per effetto del real decreto del 1 luglio 1846. La popolazione poi “all’ingiustizia statale” cominciò a preferire la giustizia semplice, il “fai da te”, insomma il linciaggio. Ma torniamo a Filippo Scoglio la cui triste vicenda non era ancora per niente finita. Nell’indifferenza generale e senza che alcuno avvertisse la moglie Rosa o qualche autorità, rimase agonizzante in contrada Fisacchi, “quasi sepolto sotto l’enorme massa delle pietre scagliategli” dal 10 settembre fino al mattino di due giorni dopo. | Il giudice ricorda nella sua sentenza come dalle indagini si fosse chiarito inoltre «che la sera del giorno medesimo (10 settembre 1855) il Sanfilippo ritornava nel luogo Fisacchi ove avea lasciato quasi esanime lo Scoglio, e ciò per accettarsi, se costui fosse tuttora vivo o morto, e con lui recaronsi il detto Sciacca, Luigi Prestianni, ed Antonino Buscemi, e non trovandolo morto, lo richiesero se avea ancora veleno e se ne avea sparso, ma quello infelice rispondea con segni negativi.» «La sera stessa, il detto Sanfilippo, recatosi nella casipola in contrada Barbaro, ove era Giovanni Furnari, gli annunziò che lo Scoglio era ancor vivo, e quindi premurava i villici, che colà trovavansi, a finirlo, dicendo loro che, rimanendo quegli fra i viventi, avrebbe provocato contro i suoi offensori il rigore della legge, ma quelli non vi acconsentirono.» Nella vicenda sembra apparire, finalmente, un barlume di umanità. Ma fu solo un guizzo, un lampo perche «la dimane, (la mattina dell’11) lo Sciacca, in compagnia del ragazzo Francesco Russo e Nunzio Fiorella, ritornarono in contrada Fisacchi; ed avvicinatosi esso Sciacca al misero Scoglio, presa con ambo le mani una grossa pietra, gliela scagliò per ischiacciarlo. A tale strazio lo infelice si sollevò alquanto, ma subito ricadde.» E lo lasciarono lì agonizzante; tutti sapevano ma nessuno intervenne o avvisò la famiglia o denunciò il fatto alle autorità. Il giorno seguente (12 settembre 1855) ritornarono sul luogo «il truce Sciacca con Antonino Giarrizzo, e tutti e due, facendo uso di un buon grosso bastone, fieramente il percossero, quando quegli esalò l’ultimo respiro.» Per il povero Filippo Scoglio, vittima innocente di una insulsa credenza popolare e dell’odio dei “villani” contro lo Stato e la borghesia dell’epoca fu la fine. Ma i suoi assassini non la fecero franca perché già il giorno dopo con fulminea rapidità lo Sciacca, il Sanfilippo ed il Furnari furono «assicurati alla giustizia e sottoposti allo interrogatorio, hanno rafforzato vieppiù la prova della loro colpabilità.» Più che l’atroce delitto furono le «vociferazioni sediziose di spargimento di veleno dirette a turbare la interna sicurezza dello Stato» a dare impulso e velocità alle indagini ed a far condannare gli assassini. Alcuni decenni dopo (1887) il povero Filippo Scoglio ebbe in qualche modo la sua vendetta: una violenta epidemia di colera colpì la popolazione brontese causando oltre 400 morti.
Ma la credenza popolare sullo "spacciator di veleni per propagare il colera" resisteva ancora se nel 1895 il medico-poeta brontese Filippo Isola così scriveva ("Prosa rimata", Adernò, Tipografia Luigi Longhitano, 1898) ... Per la folle opinione che il colera
da birbi indemoniati si dispensa,
come l'ombre distendonsi la sera
la gente in casa a ripararsi pensa,
stoppa d'usci e finestre le fessure
e rinforza ben ben le serrature. ... (nL
- Agosto 2009) |
| IL «CONSIGLIO» DEL SANFILIPPO Ad uno degli assassini, D. Filippo Sanfilippo,– difeso dall'avv. D. Sebastiano Carnazza - si aggiunsero altre imputazioni: «Contro di lui si è stabilito, - recita la sentenza - che nel mentre la forza pubblica di Bronte, incaricata pel di lui arresto, stava procedendo, e lo arrestava nel 13 settembre 1855, dopo averlo condotto nel posto di buon ordine per esser legato, audacemente, dopo essergli riuscito vano ogni sforzo per impugnare uno dei fucili in detto posto esistenti, si ebbe la temerità di resistere per via di fatto contro la forza che lo arrestava, e che dileggiandola con gravi ingiurie e schiamazzi, la minacciava, e slanciandosi contro il capo ronda per guadagnargli il nerbo di bue che teneva in mano, sicchè disgombrando questi la folla che ci accorreva occasionalmente alle grida dello arrestato, nella colluttazione e nel contrasto glielo ruppe.» Questa la tesi che l’avvocato difensore di FIlippo Sanfilippo, Sebastiano Carnazza, sostenne davanti alla gran Corte: «Dai fatti ritenuti nell’atto stesso di accusa non risulta punto la voluta complicità. Secondo gli stessi Sanfilippo non fu presente, quando la mattina del 10 settembre lo infelice Scoglio fu inseguito e lapidato, se indi sopravvenne armato di fucile non disse altro a quei facinorosi che di bruciarsi le vestimenta di lui, ma ritrattatosi tantosto disse meglio frugarsi le robe di costui, quando si rinvenne la carta proveniente dalla cancelleria, ed allora tutti si ritirarono, non avendo preso alcuna parte detto Sanfilippo, nè allo inseguimento, né alla lapidazione di quel misero. L’accusa dice che la sera di quel giorno 10 settembre, il Sanfilippo ritornava sul luogo per vedere se lo Scoglio fosse estinto. Ma ciò non costituiva una complicità. Se poi il Sanfilippo al dir dell’accusa premurava alcuni dei ribaldi a finirlo, poichè restando fra i viventi avrebbe parlato contro i medesimi, locchè quelli non fecero allora, al dir di detto Sanfilippo, non era che un semplice consiglio, ma questo non costituisce complicità.
Se poi il detto consiglio fu infruttuoso e non secondato, non vi è affatto elemento di complicità di alcuna specie. (…) Se poi ruppe il nerbo al capo ronda, ciò non poteva verificarsi, se non perchè il capo ronda lo percuoteva con esso, e glielo teneva sulla faccia, mentre essendo quegli legato alla militare non poteva in altro modo afferrarlo…» |
|
| |
|